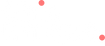Periodica Magazine: lo spazio per il dialogo aperto
Questa sono io e qui comando io
C’è una società diretta esclusivamente da una regina, che va avanti da oltre 100 milioni di anni e si estende su tutto il pianeta. No, come potete immaginare non ha nulla a che vedere con l’Inghilterra, anche se l’inno dei Sex Pistols le si addice comunque. Si tratta della società, osiamo dire matriarcale, delle api. Il capo supremo è appunto la regina, membro dominante e - letteralmente - madre di tutte le api presenti nell'alveare. È l'unica femmina che viene fecondata e che è quindi in grado di deporre uova e di conseguenza preservare la colonia. L'ape regina è anche responsabile della regolazione della temperatura e dell'umidità all'interno dell'alveare e della difesa dalle minacce esterne. All'interno della colonia vige una gerarchia ben definita e le api operaie (anch’esse tutte femmine) lavorano insieme per svolgere le diverse attività necessarie. Forse per ironia della sorte, in una società così longeva i fuchi, ovvero i maschi, non hanno affatto ruolo dominante: sono più piccoli e non hanno il pungiglione, non possono dunque difendere l'alveare. Il loro compito è principalmente quello di fecondare la regina, a volte di curare i piccoli e ‘pulire’ le celle in cui vengono deposte le uova. Il resto del tempo lo passano letteralmente a gironzolare perché, a differenza delle femmine operaie, non sono per genetica in grado di bottinare nettare e polline. Il matriarcato, in generale Tornando a parlare più in generale, il matriarcato - come facile intuire - è una forma di società in cui le donne svolgono un ruolo dominante nella famiglia, nella comunità e nella politica. Detengono loro il potere decisionale finale su questioni importanti che riguardano la famiglia o la comunità. Il matriarcato è da sempre al centro di studi e di dibattiti e le posizioni su di esso sono ancora molto contrastanti. Alcuni vi riconoscono un modello di società più equo e armonioso rispetto ad altri e soprattutto al patriarcato, mentre altri sostengono che sia meno efficiente e meno adatto a promuovere lo sviluppo economico e sociale. Altri invece sostengono che, alla stregua delle api, il matriarcato tra gli esseri umani si sia sviluppato ben prima del patriarcato: c’è infatti un dibattito sulla possibilità che il matriarcato fosse presente già nel neolitico. Tuttavia, le prove a sostegno di questa tesi sono ancora poche e controverse. Società matriarcali e dove trovarle Società matriarcali sono state osservate ovunque, ma sono più comunemente associate con le società indigene e tribali in Africa, Asia e America Latina. Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che il matriarcato sia stato presente anche in alcune società antiche dell'Europa. Seppur non esista un vero elenco ufficiale, ecco alcune delle più note e interessanti realtà matriarcali del mondo: Umoja, Kenya: in questa società la presenza di uomini è totalmente vietata. A Umoja vivono al sicuro tutte le donne di Samburu che hanno subito stupri, matrimoni forzati, abusi domestici e mutilazioni genitali. I Khasi, India: quella dei Khasi è considerata la più grande cultura matrilineare del mondo. La loro popolazione è di oltre 1 milione di persone ed è guidata da donne. Qui i bambini prendono il cognome della madre e la nascita di una bambina è sempre motivo di grandi celebrazioni, mentre la nascita di un maschio è semplicemente accettata. Popolo Mosuo, Cina: come per le api, qui il capo di tutto è la matriarca che si occupa della maggior parte delle questioni tra cui il denaro, il lavoro, i rapporti tra le persone. Una curiosità: qui marito e moglie vivono in case separate e si vedono solo di notte. I Navajo, USA: in passato erano tradizionalmente un popolo matriarcale. Il capofamiglia era sempre la donna ‘la prima persona a svegliarsi e l'ultima ad addormentarsi ogni giorno’. Lignaggio, beni e proprietà erano generalmente passati attraverso il lato materno della famiglia. Oggi la loro società è ormai quasi totalmente priva di gerarchia. Seppur il matriarcato sia stato spesso descritto come un sistema basato sulla cooperazione e il mutuo sostegno, in cui le donne lavorano insieme per il benessere comune della famiglia e della comunità, alcuni critici riconoscono nelle società matriarcali disuguaglianze di genere, nonostante l'assunzione di ruoli di leadership da parte delle donne. Per altri studiosi il matriarcato resta solo una forma di resistenza al patriarcato e alle relative pratiche oppressive, piuttosto che come una forma alternativa di organizzazione sociale. Bonus track: il Re Leone è una bufala Oltre alle api, il regno animale è pieno di società matriarcali: elefanti, bombi, orche, lemuri e formiche sono solo alcuni esempi. Forse dicendo questo vi rovineremo un po’ l'infanzia, ma dovete saperlo: il leone non è il re della giungla. Sono le leonesse, infatti, ad essere incaricate della sopravvivenza dell’intero branco (maschi compresi). Sono loro a cacciare e inseguire le prede oltre che a garantire lo sviluppo della prole e ad avere ‘potere decisionale’ su ciò che concerne il branco. EMILIA BIFANO
Saperne di piùIl diritto all’aborto esiste realmente in Italia?
“L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale Inveiva contro casi come il nostro, indi per cui Avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare Per dirgli: "È facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui” È emblematico Ernia nel ricordare a tutti come il diritto delle donne all’accesso all’interruzione di gravidanza (IVG), cioè di abortire in modo sicuro e legale, sia ancora continuamente attaccato nel dibattito pubblico e come alle donne venga fatta pesare questa scelta, come se fosse una colpa.Una colpa che, però, non esiste.Sono soprattutto gli uomini, infatti, a pensare di poter prendere le decisioni per le donne, riguardo ai loro diritti, alla loro vita e alle loro scelte. Che anche la salute di una donna sia una loro decisione. “Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo Aveva un che di punitivo, tipo un messo in castigo Ma nelle sale d'attesa ho capito Temono che l'uomo possa fare pressione di qualche tipo” Purtroppo, non sono solo questi a fare questo tipo di pressioni, nonostante Ernia sottolinei in maniera esemplare come si comporti la figura maschile: in maniera autoritaria, egoista, patriarcale.Sono altrettante, però, le donne che commentano, condannano e insultano altre donne per l’applicazione di quello che è un loro diritto e, conseguentemente, una loro scelta. Un diritto che è da difendere più che mai. Anche se per Eugenia Roccella, la Ministra per la Famiglia, la Natalità e per le pari opportunità l’aborto non è un diritto.Anzi, è il “lato oscuro del materno”, a detta sua.Una dichiarazione preoccupante da parte di una ministra del governo italiano, anche se, senza troppe sorprese, è ciò che ci si aspettava da questo nuovo governo.Un governo votato alla negazione dei diritti e dell’inclusività, alla negazione di una corretta informazione scientifica - come dimenticarsi delle affermazioni del sottosegretario al Ministero della Salute Gemmato nei riguardi dei vaccini – e una visione distorta dell’Italia, fatta di bigottismo, nazionalismo e, per non far mancare nulla, di fascismo.“Dio, patria e famiglia”, come avrebbero detto i balilla una volta. E quelli che ci sono ancora adesso, dentro e fuori i palazzi di governo.Una trinità che non comprende le diversità culturali e l’immigrazione, ma, anzi, che ricolma i propri gesti di razzismo, molte volte esplicito.Una realtà che è avversa alla comunità LGBTQIA+ e al diritto delle donne all’aborto, soprattutto se consideriamo che lo Stato italiano è uno stato laico.Non cattolico.Quante, infatti, sono le pressioni anche da parte della Chiesa sull’Italia in termini di diritti umani e di aborto, andando a negarli come diritti in quanto tali, in direzione completamente opposta agli altri Stati europei. Non è sbagliato, però, affermare che l’aborto non sia un diritto. Perché nel nostro Stato non lo è.La 194, infatti, non si basa sull’affermazione positiva del diritto all’aborto, ma regolamenta i casi in cui l’aborto non viene considerato un reato.La legge si intitola “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” e all’Art. 1 dice che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». Questa, infatti, nasce per limitare il problema degli aborti clandestini, a livello sanitario, e tutela esclusivamente il diritto alla salute fisica e psichica della donna, ma non lascia spazio all’autodeterminazione personale della donna. Sin dalla sua approvazione, la legge è stata fortemente e continuamente attaccata, sia cercando di sfruttarne alcune sue ambiguità, sia giocando sulla sua applicazione, che di fatto rimane ancora molto limitata, nonostante il 12 agosto 2020 sia stata diffusa la circolare sull’aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza fino a nove settimane compiute di età gestazionale (quindi non più sette) presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori oppure day hospital.Fin da subito i movimenti femministi segnalarono che nel testo della 194 fossero e sono ancora presenti criticità importanti, che minano lo stesso diritto alla salute, prima fra tutti quella dell’obiezione di coscienza (che non si limita al solo al personale medico, ma comprende anche quello amministrativo), utilizzata come deliberata azione di boicottaggio e che, purtroppo, non rimane l’unica.Al momento in Italia la maggior parte degli aborti volontari viene eseguita entro la decima settimana di gravidanza, anche se una piccola percentuale di donne chiede l’IVG quando il limite è ormai superato, magari dopo aver ricevuto una diagnosi tardiva di grave patologia o malformazione fetale, costringendo a un’unica alternativa, ossia quella di recarsi all’estero per accedere all’aborto terapeutico.Infatti, anche se raccomandato dalle principali società scientifiche internazionali, in Italia nessuno esegue l’aborto “terapeutico” oltre la ventiduesima settimana, per non rischiare di dover rianimare un feto gravemente malato che dovesse nascere vivo.Una legge che nega il diritto alla salute e che obbliga ad andare all’estero anche una sola donna non è una legge giusta.E non garantisce veramente un diritto. C’è bisogno di una legge nuova, che possa finalmente intrecciare due diritti fondamentali, quello alla salute e quello all’autodeterminazione.A più di quarant’anni dall’approvazione della 194, la legge ha mostrato, infatti, non solo i moltissimi problemi legati alla sua mancata applicazione - per cui l’Italia è stata più volte richiamata dalle istituzioni europee - ma anche i limiti che dipendono direttamente da quello che contiene.E a proposito di applicazione, Fratelli d’Italia, partito capitanato da Giorgia Meloni, propone «la piena applicazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, a partire dalla prevenzione – quindi di non arrivarci mai all’aborto per loro – e l’istituzione di un fondo per aiutare le donne sole e in difficoltà economica a portare a termine la gravidanza». Sempre la Meloni continua: «Non mi risulta sia accaduto da nessuna parte che una donna che voleva interrompere la gravidanza non abbia potuto farlo. Il diritto all’aborto in Italia è sempre stato garantito».Ed è qui che ti sbagli Giorgia.Riferendosi a quei contestatori che dicono che in Italia c’è un problema di accessibilità all’interruzione volontaria di gravidanza a causa dell’alto numero di obiettori di coscienza, sempre la Meloni ha detto: «Però c’è anche la coscienza delle persone, non possiamo costringere le persone a fare cose che in coscienza non si sentono di fare. Bisogna garantire la libertà. Io credo che l’equilibrio che si è creato sia un equilibrio che attualmente tiene».Come può, allora, una donna essere libera di scegliere se nella propria città e nella propria regione non resta neppure un medico non obiettore? Come può esserle garantito un suo diritto? Che razza di equilibrio è questo?Allora perché non dimostra la stessa preoccupazione nel garantire la libertà di poter accedere a un diritto sacrosanto? Questa, però, è una cosa che i loro partiti e le associazioni pro-vita, alle quali strizzano gli occhi, non vogliono garantire. E a tal proposito Emma Bonino, in risposta alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, dice: “Nessuno obbliga un medico a fare il ginecologo se è obiettore di coscienza e nessuno può obbligare una donna ad andare in una regione diversa dalla sua per abortire. Le istituzioni devono garantire questo diritto conquistato, punto. Se la legittima libertà di coscienza dei medici mette a rischio la libertà e la salute delle donne, semplicemente si trasforma in violazione di un diritto». Infatti, com’è possibile garantire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza se la situazione è questa? Dall’analisi dei dati ottenuti da Regioni, aziende ospedaliere e ASL, ne è risultata una prima mappa che ha mostrato chiaramente che le cifre ottenute e che sono sottostimate: vi sono infatti molti specialisti che pure non essendo espressamente obiettori, di fatto non praticano l’IVG. L’inchiesta ha individuato 31 strutture (24 ospedali e 7 consultori) con il 100% di obiettori di coscienza, a cui se ne aggiungono quasi 50 con una percentuale superiore al 90% e più di 80 con un tasso di obiezione superiore all’80%. Il problema è che la Relazione ministeriale non fa emergere il dettaglio territoriale, che permette di capire veramente dove manca il servizio che possa garantire il diritto all’IVG. La 194 stabilisce, però, dei limiti molto chiari all’obiezione di coscienza: dice innanzitutto che lo status di obiettore riguarda esclusivamente la pratica, ma niente che sia tecnicamente precedente o successivo alla pratica stessa, come ad esempio la consegna del documento che attesti lo stato di gravidanza e la volontà della donna di interromperla, documento che è necessario per l’aborto. Stabilisce che l’attestazione necessaria per accedere all’IVG possa essere rilasciata da un medico del consultorio, della struttura sociosanitaria o dal medico di fiducia e dice che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenute in ogni caso ad assicurar» che l’IVG si possa svolgere.Stabilisce quindi che l’obiezione debba riguardare il singolo medico e non l’intera struttura.Come in Lombardia, una delle regioni dove si spende meno per la medicina territoriale e dove i consultori privati accreditati di ispirazione cattolica hanno già dal 2000 la possibilità di fare “obiezione di coscienza di struttura”.Una situazione illegale e completamente ingiusta.Per questo, l’obiezione di coscienza entra in conflitto con il diritto alla tutela della salute della donna quando non c’è equilibrio tra il numero di obiettori e di non obiettori, perché ci sono delle responsabilità nell’erogazione di un servizio che deve essere garantito per legge. Per questo, come dice Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, è necessario un albo pubblico dei medici obiettori, perché le donne che vogliono interrompere una gravidanza devono sapere quale sia l’orientamento del loro medico. E soprattutto sapere che possono accedere facilmente all’interruzione, favorendo sempre più quella di tipo farmacologico, senza dover intervenire chirurgicamente e senza obbligo di ricovero. De-ospedalizzare l’aborto significa, da una parte, riorganizzare i servizi ma, d’altra parte, una maggiore possibilità di autogestione da parte delle donne. Anche qui, però, i problemi non sembrano finire, nonostante le nuove linee guida del 2020 a favore dell’interruzione farmacologica e della de-ospedalizzazione di quest’ultima, costituita dall’assunzione al giorno uno di mifepristone (la famosa RU486) e del misoprostolo (prostaglandine), che si assume il terzo giorno per via buccale o sublinguale (la pasticca va sciolta lentamente tra le pareti della bocca e non inghiottita intera) o vaginale e che provoca l’espulsione. Infatti, i partiti di destra e le organizzazioni integraliste pro-vita hanno fatto un fronte comune: in alcune regioni hanno apertamente boicottato il diritto delle donne di poter scegliere per la propria salute. Nel 2019, in Umbria, Donatella Tesei, esponente della Lega, aveva firmato un “Manifesto valoriale” promosso da sette associazioni antiabortiste per sostenere «la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna» e «la vita, dal concepimento fino alla morte naturale». Una volta eletta, e coerentemente con quanto sottoscritto, Tesei aveva abrogato una legge regionale approvata dalla precedente amministrazione di centrosinistra che prevedeva l’assunzione della RU486 in day hospital, costringendo le donne al ricovero per l’accesso all’IVG. A fine gennaio, la maggioranza di centrodestra delle Marche guidata da Fratelli d’Italia aveva deciso di opporsi all’aborto farmacologico e alle nuove linee di indirizzo ministeriali per la piena applicazione della 194 in una regione dove su 137 ginecologi ospedalieri, 100 sono obiettori di coscienza. Il capogruppo al consiglio regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, per giustificare le limitazioni all’uso della pillola abortiva, aveva citato l’imminente pericolo di una «sostituzione etnica», sostenendo che in loro assenza aumenterebbero i bambini con genitori “stranieri” e diminuirebbero invece quelli italiani. A inizio febbraio, la regione Abruzzo – governata da Marco Marsilio di Fratelli d’Italia – ha inviato una circolare alle Aziende sanitarie locali «affinché l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mifepristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari». Al Consiglio regionale della RegioneLiguria, Fratelli D’Italia si era astenuto dall’ordine del giorno presentato dal PD sull’accessibilità all’IVG nelle strutture sanitarie del territorio. La quarta commissione della RegionePiemonte aveva, invece, approvato una delibera per istituire il “Fondo Vita Nascente”: 460 mila euro per organizzazioni e associazioni pro-vita per il biennio 2022-2023. A fine settembre, su iniziativa di Fratelli d’Italia e con il sostegno del presidente Alberto Cirio di Forza Italia, aveva diramato una circolare che non solo mette in discussione le nuove modalità di accesso alla pillola abortiva RU486 nei consultori (la vieta), ma finanzia e rafforza l’ingresso delle associazioni antiabortiste negli ospedali pubblici. Prevede infatti l’attivazione di sportelli informativi pro-vita all’interno degli ospedali che praticano IVG. Ultima, ma non ultima: il senatore di Forza Italia Gasparri, alla prima seduta a Palazzo Madama, ha presentato un Ddl per modificare l’Art. 1 del Codice civile in materia di “riconoscimento della capacità giuridica del concepito”. Nonostante i continui attacchi e i continui ostacoli, noi di This Unique non smetteremo di lottare e di fare una corretta informazione. Di combattere e fare opposizione perché i diritti di ogni singola donna vengano rispettati. Affinché ogni donna, se ne avrà bisogno, possa accedere all’aborto senza alcun impedimento. Perché ognuno di noi possa vivere la propria vita con il pieno rispetto dei propri diritti. LORENZO CIOL
Saperne di piùCRAFTHERAPY: il potere rilassante dell'artigianato
Conosci la dopamina? Si tratta della “sostanza chimica del piacere”. Il suo rilascio potrebbe essere provocato dall’odore del tuo cibo preferito, dall’attività sessuale, da un intenso workout… o da una sessione di crafting. Diversi studi hanno infatti dimostrato che “fare a mano” può essere terapeutico: proprio come accade durante la meditazione, ritagliarsi un momento per lavorare la ceramica, riparare un oggetto caro o realizzare un capo in crochet, permette di distrarsi dai problemi quotidiani e liberarsi dallo stress, favorendo una maggiore chiarezza mentale e concentrazione. Le ricerche sull'impatto del crafting sulla salute mentale si sono focalizzate soprattutto sul knitting. Ma c’è una buona notizia: non importa la tecnica! Si possono infatti ottenere gli stessi effetti da qualsiasi attività, che sia fare un gilet ai ferri, una giacca con il quilting o intrecciare una borsa in macramè. Abbiamo selezionato 3 diversi progetti per tutti coloro che sono curiosi di sperimentare in prima persona i benefici della craft-therapy (ovviamente tutti beginner-friendly!). • GRANNY SQUARE Li abbiamo visti su cardigan, borse e top: i Granny Square sono stati tra le più grandi tendenze del 2022. Queste mattonelle - generalmente realizzate all’uncinetto - possono essere considerate l’antonomasia della craft-therapy. Costituiscono infatti singolarmente un progetto a sé, ma sono un modulo che ripetuto e assemblato può dar vita a capi, coperte o accessori. Dover ripetere gli stessi movimenti più volte, vi aiuterà sicuramente a liberare la mente. Proprio con dei Granny Square, abbiamo realizzato questa fascia: guarda il video e prepara gli uncinetti! https://www.instagram.com/reel/CZHwYuNB9IR/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.youtube.com/watch?v=14s2g62cuB8 • DIVERTITI CON LA CERAMICA Se da bambin* eri un* grande fan del DAS, questa è la tecnica che fa per te! Guarda il nostro video in collaborazione con This, Unique e crea il tuo vaso di ceramica. Avrete bisogno semplicemente di un panetto di argilla… e delle vostre mani! https://www.instagram.com/reel/Cl0u-V_D47z/?utm_source=ig_web_copy_link • REALIZZA DEI PASTELLI IN CERA Se senti il bisogno di riconnetterti con la natura e diventare più consapevole e responsabile, segui Maibie nella creazione di pastelli naturali. Siamo sicure che nelle vostre cucine ci sono tutti i pigmenti vegetali di cui potreste avere bisogno: cacao, curcuma o frutti di bosco! https://www.instagram.com/tv/CIDd8okITwG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Saperne di piùVIOLENZA GINECOLOGICA
Mi ci è voluto qualche anno e una consapevolezza più profonda, regalatami dall’informazione sempre più preziosa e attenta divulgata dalle attiviste che si prodigano in questo ambito per una nuova educazione contro la violenza e per l’eliminazione dei tabù di genere, per rendermi conto che la violenza ginecologica è un fenomeno dalle molte sfaccettature. Esistono quelle più cruente e riconoscibili, ma anche quelle più silenziose, che si insinuano nell’animo in maniera silente ma costante, che esprimono un disagio facendoci costantemente interrogare sulla validità del nostro sentimento. Facendoci rimanere continuamente sul filo del rasoio, sospettosamente in bilico. Quelle violenze definibili dalla società “non violenze” che ci fanno domandare: ma è successo davvero o no? Come se quello che abbiamo sentito o provato fosse qualcosa di esagerato. Come se stessimo sbagliando a sentirci così. Il punto è che non stiamo sbagliando. Ed è il momento di rovesciare la situazione. Soffro di vulvodinia da molti anni e prima di aver ricevuto una diagnosi adeguata sono entrata e uscita da diversi studi ginecologici senza mai ricevere un riscontro medico attendibile e soprattutto credibile. Il dolore e il disagio erano etichette sempre nuove e sempre diverse, che mi trovavo appiccicate addosso ogni volta che uscivo da quelle porte. Il primo ricordo che ho di questo tipo di dolore, risale all’incirca ai miei 15 anni, in concomitanza con i miei primi rapporti preliminari. Di lì a poco mi sarei sottoposta alla prima visita ginecologica. Ricordo benissimo, purtroppo, quel giorno: entrai nella sala insieme a mia madre e vidi questa donna di circa mezza età, che mi disse in modo poco attento alla mia giovane età e senza modi gradevoli, di sdraiarmi sul lettino e nel frattempo mi fece qualche domanda. Pochi secondi dopo iniziò a visitarmi e iniziai a provare fitte e bruciore e lei, come il manuale del gaslighting insegna, disse che il mio dolore derivava semplicemente dal fatto che fossi ancora vergine. Nonostante il mio tentativo di fermarla e di spiegare che fosse qualcosa di troppo doloroso e acuto per essere ricondotto a quello che immaginavo all’epoca essere il "dolore da rottura di imene” – del quale mi ero fatta un'idea in base ai miei stessi rapporti fisici, e grazie ai racconti di conoscenti e amiche –, venni completamente ignorata. C’è da dire anche una cosa importante: sono sempre stata, fino a qualche anno fa, una ragazza incapace di far sentire la mia voce e di combattere per i miei diritti, motivo per cui capirete meglio come, da figure professionali e mediche che dovrebbero avere in mano la nostra salute, ascoltarci e tutelarci, sia stato per me e immagino sia più facile anche per molt* altr*, sentirsi soverchiati, poiché vulnerabili. Ma torniamo a quella che fu la mia prima visita. Come avete letto, le mie parole e il mio dolore non furono degni di tanta considerazione ma, come se non bastasse, il tutto si concluse con l’inserimento all’interno del canale vaginale di un ovulo che iniziò a bruciare a più non posso, il cui effetto indesiderato non mi permise di camminare o di scendere dalla macchina per circa un’ora e mezza. Ebbene sì, rimasi seduta sul sedile della macchina di mia madre senza scendere o entrare in casa per tutto quel tempo. In risposta al dolore provato fatto immediatamente presente in studio e alla richiesta di toglierlo poiché insopportabile, ricevetti in risposta un candido “su su, dopo un po’ passa” dalla ginecologa. Inutile dire che da quel momento in poi non misi più piede in uno studio ginecologico per molto tempo, per la paura di riprovare un dolore simile al quale non potevo oppormi. Il secondo episodio di violenza ginecologica è avvenuto qualche anno dopo. Avevo all’incirca 19 anni e, dopo continui episodi di dolore che erano ovviamente dissociati dalla mia prima “diagnosi”, avevo deciso di andare in un altro studio ginecologico per ottenere delle risposte e capire se i miei sospetti fossero effettivamente fondati. Questa volta la ginecologa sembrava abbastanza rispettosa e gentile: parlammo molto, io espressi i miei dubbi riguardo quella che era la mia condizione e lei mi ascoltò comprensiva e mi illustrò quello che sapeva della mia patologia (cioè poco o nulla), cercando di farmi capire un po’ meglio come affrontarla in futuro, chiarendo che fosse necessario rivolgersi a uno specialista qualificato. Dopo il colloquio di circa mezz’ora arrivò il momento della visita e, non avendone io fatta fino a quel momento una con attrezzi interni, non sapevo né a che cosa sarei andata incontro e nemmeno che cosa avrei potuto provare. D’un tratto, senza spiegazioni né attenzione al mio dolore precedentemente illustrato durante il colloquio conoscitivo, la ginecologa infilò lo speculum. Nonostante continuassi a dirle ad alta voce che provavo un dolore atroce e che non riuscivo più a resistere, fino a contorcermi sul lettino, lei proseguì con l’ispezione finché non ebbe finito. Questa esperienza mi è servita per capire che la violenza ginecologica non è solo essere vittime di un comportamento inadeguato, irrispettoso o crudele: si verifica anche nel momento in cui si superano i limiti del paziente per cercare di fare il “proprio lavoro”, senza porre troppa attenzione ai suoi bisogni in nome di un fine considerato giusto, cioè quello di ottenere risposte sulla condizione medica a dispetto del dolore derivante dalle procedure stesse. La terza e ultima esperienza di “violenza” ginecologica è capitata non molto tempo fa, proprio in concomitanza con la diagnosi effettiva di quello che è il mio dolore cronico. In questo caso, il rispetto nei miei confronti non è mancato nell’ambito fisico, bensì in quello psicologico che ha peggiorato, come un loop infinito, la condizione di quello fisico. Nonostante avessi espressamente richiesto la presenza del mio fidanzato all’interno della stanza in cui si doveva tenere la visita, è stato allontanato senza alcun motivo effettivo ignorando il mio volere, perché, secondo il parere della ginecologa, poteva essere un elemento di disturbo. A smontare questa tesi ci sono due nozioni che vanno chiarite: punto primo, il mio ragazzo è uno studente di medicina al 6° anno ed è stato lui ad aiutarmi a capire meglio la mia malattia e a comprendere cosa stavo affrontando. La sua presenza quindi, oltre ad essere confortante per me, poteva essere un punto a favore per spiegare ciò che io, tecnicamente, non sapevo descrivere, e un tramite prezioso per raccontare come la vulvodinia impattasse la mia quotidianità, da lui vista e osservata da tempo. Punto secondo, di lì a poco, nella stanza in cui si sarebbe tenuta la visita, a mia totale insaputa, ci sarebbero state altre 4 specializzande in ginecologia presenti per tutto il tempo: non solamente durante il colloquio, ma anche durante l’esame stesso, letteralmente piegate su di me. Oltre al fatto di non essere stata minimamente avvisata della partecipazione di altre persone a me estranee in principio, non mi è stato nemmeno chiesto se, data una condizione clinica così particolare, che personalmente trasporta l’agitazione e il disagio emotivo a uno stato fisico che aumenta il dolore, preferissi restare da sola con la dottoressa. Sono stata quindi osservata da 5 persone come un caso clinico da studiare, diventando del materiale didattico da utilizzare per una dimostrazione. Il tutto senza conforto del mio ragazzo per quanto riguarda il dolore che sapevo avrei provato durante lo swab test (un test che consiste nel toccare con un cotton fioc inumidito la vulva in punti specifici e che nelle persone affette da vulvodinia risulta doloroso) che si è aggravato poi a causa della condizione disagevole nella quale mi trovavo perché ero molto tesa. Come se non bastasse, anche la stessa visita è risultata ai miei occhi parzialmente vana perché, a causa dell'imbarazzo provato, non mi sono esposta chiaramente, bypassando alcune cose molto personali che non sentivo di condividere con le specializzande. Quando si dice tanto dolore per nulla. Infine, le mie esperienze si possono in qualche modo ordinare in fase decrescente di riconoscibilità della violenza. L’evidenza di essere stata vittima di un episodio del genere si è fatta sempre più difficile da individuare nel tempo, poiché da un episodio lampante sono passata a quella serie di domande e dubbi di cui parlavo all’inizio. “Si può definire tale?”, “magari ha solo fatto il suo lavoro” e così via. Quello che però ho capito grazie a questi avvenimenti è che se, in qualche modo siamo portati a domandarci se qualcosa di sbagliato sia avvenuto, forse, è perché è così. Non dico che debba essere necessariamente definita violenza ginecologica qualsiasi esperienza negativa, ma che la cosa importante sia interrogarsi senza paura e dare voce ai nostri dubbi, senza metterli a tacere a priori perché non conformi a quello che fino ad ora ci ha insegnato la società. Siamo noi a dover stabilire i limiti personali del nostro corpo e della nostra mente e, se questi non vengono rispettati, farlo presente senza paura come atto di rispetto verso noi stessi. MARTA BORASO
Saperne di piùLA MIA AMENORREA
Sono passati già 4 anni, e credo che non potrei mai più raccontare una parte della mia storia se non ci aggiungessi, ora come ora, le riflessioni fatte durante questo tempo trascorso. Tempo che mi è servito per capire e per imparare da, probabilmente, la lezione più dura che abbia mai ricevuto in vita mia.Non parlo spesso di quando ero ammalata di anoressia e per quanto, di conseguenza, non ho avuto le mestruazioni. Ed è qui che voi direte: ma come non ne parli? e i libri? i tuoi speech? Quando scrivo, entro in una zona protetta, mi rifugio dietro a semplici pagine con la convinzione che queste possano coprirmi, difendermi, nascondermi, da quel mostro chiamato giudizio o, peggio ancora, dalla più totale indifferenza. La stessa cosa vale nel momento in cui decido di fare uno speech, ritrovandomi ad accettare l’incarico solo se svolto in situazioni confortevoli che possano farmi sentire “protetta” dalle stesse parole che decido di usare e, a dirla tutta, dalle persone. In modo che, quello che decido di raccontare, possa essere ascoltato solo da chi ha veramente voglia di sedermi accanto, lasciandomi raccontare. Persi le mestruazioni dopo pochi mesi di malattia. Non ero assolutamente consapevole di soffrire di anoressia nervosa, e per quanto avessi sempre desiderato avere le mestruazioni, per sentirmi più donna nel senso più etimologico del termine, quell’assenza improvvisa di vita non mi turbò affatto. L’anoressia mi aveva completamente infettato la mente, perciò conclusi il tutto con un semplice “eh, vabbè.. niente più dolore e rotture, tanto i figli non li voglio”. Accade qualcosa di strano, quando sei anoressica. Il tuo corpo “deve” adattarsi alla tua rigidità mentale, non è altro che una cosa da sistemare, il punto numero 1 di una lista senza fine appesa al frigorifero, un imprevisto visibile che ti impedisce di essere quella che vorresti: mentalmente leggera. Come se il peso del nostro corpo, in quel momento, potesse definire quella pesantezza dell’anima che si tenta in tutti i modi di alleviare. Come se non fosse altro che una ricerca distorta e disperata di una libertà e un’ indipendenza che sembra andare ben oltre quelle semplici linee che definiscono la forma del nostro corpo. Fu per questo che fui quasi felice di non avere più alcun legame con quella Valentina “pesante” di cui volevo disfarmi da tempo, celebrando la fine biologica di qualcosa che avevo definito male, che avevo sempre visto come un impedimento e non come un segno della salute del mio corpo e, di conseguenza, della mia mente. Volevo sentirmi diversa dalle altre donne, da tutte le altre persone, dimostrando a me stessa che la mia forza di volontà avrebbe potuto fermare ogni flusso naturale della vita. Volevo sentirmi potente. E mi ci sentii. E così, il mio universo si sdoppiò. La realtà mi diceva: “se non hai più le mestruazioni significa che c’è qualcosa che non va. Chiama il dottore” ma la mia mente gridava: “Sta andando tutto come deve andare”. Fu il primo segnale che il mio corpo cercò disperatamente di inviarmi, fu il primo cartello ad indicarmi che, purtroppo, mi ero persa. Se le mestruazioni, nell’immaginario comune, denotano anche un senso di forte appartenenza al gruppo delle donne (cosa che non condivido), io non ne volevo assolutamente fare parte. Non mi ero mai sentita accettata da loro e desideravo, inconsciamente, scostarmi dalle stesse ma soprattutto da quell’idea stereotipata del femminile che, ancora oggi, tende a perseguitarci. Come se l’assenza del ciclo, potesse aiutarmi a farmi sentire così, libera dal sessismo degli uomini ma anche da quello delle donne. Come se, l’assenza del ciclo, potesse proteggermi dalla sessualizzazione e oggettificazione continua che subivo (e subisco) continuamente dagli uomini. Come se, l’assenza del ciclo e il raggiungimento di un corpo di bambina potesse rendermi indifferente a quello sguardo famelico maschile che riusciva a distruggere la mia anima e la mia persona. E, allo stesso tempo, potesse rendermi libera dallo sguardo invidioso e sprezzante delle altre donne. Godevo di un vuoto colmo di rabbia che mi ero minuziosamente creata per riuscire a sopravvivere a qualcosa di reale ma più grande di me, a qualcosa sul quale non potevo avere controllo, qualcosa che mi stava letteralmente divorando dentro. Qualcosa di cui, in realtà, non avevo colpa. “Io non sono più niente, quindi appartengo al vuoto, a quello che non c’è e che non esiste e, di conseguenza, in questo vuoto, devo crearmi una tana nella quale sopravvivere”. Scelsi inconsciamente la via della morte, dopo essere stata rifiutata ripetutamente dalla vita. Ricordo molto bene il giorno in cui mi tornarono le mestruazioni. Era estate, la stagione che odio di più in assoluto. Mi svegliai nella Residenza nella quale ero stata ricoverata molti mesi prima, totalmente ignara che, poco dopo, qualcosa di inaspettato avrebbe nuovamente cambiato il corso degli eventi. Il mio corpo stava di nuovo parlando, dopo tre lunghi anni di silenzio. Quella percentuale di malattia ancora presente nel mio corpo andò completamente fuori controllo ed io ebbi una delle più grandi crisi isteriche della mia vita. Non ero ancora del tutto guarita e accettare che il mio corpo si stesse riprendendo (e quindi tutto quel bagaglio psicologico che ho descritto prima) fu una pessima notizia per il mio disturbo alimentare. Ricordo la nutrizionista sorpresa e sorridente, incapace di nascondere le bellezza di quel momento che io vivevo con feroce rabbia. Fu anche stavolta, il ciclo, il primo segnale che il mio corpo decise di inviarmi per comunicarmi la sua volontà di rinascere, la sua volontà di fidarsi nuovamente di me, di essere pronto a riportarmi tutto quello che avevo tentato di nascondere. Fu il primo mattone visibile che la realtà decise di mettere tra me e la malattia. Mattone che fu di vitale importanza nella costruzione di quel grande muro che ancora oggi mi divide da ciò che è stato. Dalle mie paure e dai miei tormenti. Ritornare alla vita significa affrontare tutto quello che si è tentato in tutti i modi di soffocare, riappropriarsi di quel riflesso donato alle persone sbagliate. Riprendere il pieno possesso della propria vera identità, prendersi cura della propria salute, rinunciare a quell’irraggiungibile perfezione mentale e fisica che questo disturbo ti obbliga ad ottenere. Non potrei negare che quest’esperienza mi abbia cambiata nel profondo, e forse non smetterò mai di analizzarla comprendendo sempre più a fondo le diverse sfaccettature e dietrologie psicologiche che ruotano attorno a questo genere di malattie. Ma una cosa la so. E’ riuscita a svegliarmi, a rendermi molto più connessa alla realtà, alle altre persone che hanno passato situazioni simili alle mie, ai problemi che questa cultura causa alle persone più sensibili e, infine, sorpresa… alle donne. Grazie a questo ho imparato a sentirmi donna, ma donna davvero. Indipendentemente dalle mie forme, dal mio peso, dalle mie mestruazioni. Donna nel coraggio di lottare per la sopravvivenza, donna nella voglia di raccontarlo e sensibilizzarlo, donna nell’affrontare la realtà, donna nel pianto e nello sconforto, donna nella resilienza, donna nell’aiutare e aiutarsi, donna nella sorellanza e nell’empatia, donna nella ribellione e nella ricerca della verità. Donna nell’anima e non solo nel corpo. Donna dentro e nel profondo. Donna e basta. N.B. Questo articolo è relativo ala mia esperienza. Se stai vivendo un disturbo alimentare e sei in cura, non è detto che le mestruazioni tornino sempre autonomamente. Questo non significa che il tuo corpo non si fida di te, ma è tutto molto soggettivo e relativo ai dettagli del disturbo alimentare stesso (da quanto tempo ne soffri, come, eccetera). In alcuni casi, sotto scelta dei dottori supervisori, il ciclo viene stimolato non appena il fisico e la mente sono pronti per tornare alla vita. Non ci sono regole, ovviamente. Quindi nessun caso è “sbagliato”. - Be patient, take care, keep go on and never give up. :) VALENTINA DALLARI
Saperne di piùIl tempo delle donne
Quante cose si possono fare in 100 anni per le donne? Quante cose si possono fare in 100 anni? Moltissime. Eppure sembriamo non accorgerci di ciò che accade - ogni attimo - intorno a noi e di quanto peso abbia il tempo sulle nostre vite, soprattutto su quelle delle donne. Perché mentre il mondo fuori corre spasmodicamente, compiendo più azioni possibili secondo per secondo, per le donne il tempo segue un paradigma diverso e forse, leggendo questo, avrete più chiaro il perché. In 1 secondo un’ape sbatte le ali 230 volte In 1 minuto 6000 fulmini colpiscono in media la terra In 5 minuti vengono tagliati 10.200 alberi dalla foresta pluviale In 20 minuti 8.400 nuovi utenti si iscrivono a Facebook In 1 ora 108.000 stelle esplodono In 1 giorno 120.000 persone fanno sesso In 1 settimana 3 donne, in media, vengono uccise In 10 giorni 960 donne subiscono violenza In 30 giorni la Luna si allinea nuovamente con il Sole e la Terra In 90 giorni si fanno in media 450 match su Tinder In 100 giorni nel mondo si consumano circa 1.497.600.000 lattine di Coca Cola In 9 mesi la vita umana si forma nel grembo materno In 365 giorni vengono prodotti in media 1.279.502.956.800 kg di immondizia In 22 mesi un’elefantessa porta a termine la sua gravidanza In 2 anni si riversano 199.307.520.000 tonnellate d’acqua nelle Cascate del Niagara In 35 anni una donna affronta circa 420 cicli mestruali In 40 anni di fertilità una donna consuma 11.500 assorbenti In 48 anni le donne hanno ottenuto una legge che depenalizza l’aborto In 50 anni le donne hanno ottenuto l’approvazione della legge che vieta il licenziamento fino al primo anno del bambino In 72 anni e 110 giorni una donna ha tenuto in piedi uno dei regni più longevi della storia della monarchia In 85 anni le donne hanno ottenuto il diritto al voto In 92 anni le donne hanno ottenuto l’abrogazione delle disposizioni sul delitto d’onore In 132 anni (forse) il divario globale tra i sessi sarà colmato. EMILIA BIFANO
Saperne di piùArtiste e basta
L’arte al di là del genere. Non c’è bisogno di numeri o particolare dimostrazioni per dire che la storia dell’arte – l’arte nel senso più lato del termine – conta in prevalenza artisti maschi. È un dato di fatto. Basta pensare a qualunque nostro testo di scuola, dalla storia dell’arte alla letteratura (ma il campo potrebbe allargarsi) per renderci conto che la maggior parte dei nomi che saltano all’occhio, se non tutti, sono nomi di uomini. Bianchi. Non si tratta della solita retorica lamentevole del maschio-bianco-etero-cis che ha monopolizzato un settore della nostra società, e naturalmente – al di là dei gusti personali – i nomi che sono scritti con caratteri cubitali in quei libri è legittimo che stiano lì, ma, in fin dei conti, il nostro punto di vista è effettivamente distorto da una cultura patriarcale bianca (del maschio-bianco-etero-cis eccetera). Ci siamo cascat* di nuovo. Scusate. Naturalmente, il fatto che siano più i maschi consacrati nell’olimpo della nostra storia artistica non significa che le donne non sapessero farla; ma allora perché non ci sono state grandi artiste donne? È la domanda che si era posta, in tempi non sospetti, la storica dell’arte Linda Nochlin nel suo saggio forse più famoso, Why have there been no great women artists?, pubblicato sulla rivista “ARTnews” nel 1971. Nochlin scrive in tempi, gli anni Settanta, in cui la teoria femminista muoveva i suoi primi passi (dopo i primordi del primo Novecento), e decostruisce in maniera interessante il concetto stesso di “genio artistico”, troppo basato su strutture sociali e istituzionali severamente chiuse entro schemi precisi, che hanno contribuito alla costruzione di pregiudizi sociali misogini difficili da superare (le donne non possono fare arte, in poche parole). Non solo: fino all’inizio del Novecento l’istruzione artistica è stata riservata esclusivamente a studenti maschi, creando così un gender-gap notevole nella formazione individuale e nel successo artistico. La donna insomma, e lo sappiamo bene, è stata educata per altro: per essere una madre, una gentildonna, l’angelo del focolare. Non certo per permettersi tali velleità. Nochlin, in poche parole, cerca di andare al di là del concetto di opera d’arte come produzione tutta individuale figlia del genio – idea piuttosto romantica e datata, in effetti – e la interpreta piuttosto come profondamente determinata dalle strutture sociali e dalle istituzioni (le accademie, maschili, il canone, maschile). In una condizione simile, il ruolo della donna-artista era destinato a scomparire in quella stessa società maschilista e patriarcale che per secoli, e in parte ancora oggi, tutto divora e tutto omologa, stabilendo il giusto e lo sbagliato, il bello e il brutto. Dagli anni Settanta, sì, le cose sono cambiate: lo ammette Linda Nochlin stessa, che nel 2001, in occasione del trentennale del saggio, ne ha pubblicato una versione aggiornata dove riflette dei cambiamenti e della strada percorsa da allora, della maggiore inclusività dell’arte e dell’emancipazione dell’opera dal genere dell’artista. Il problema generale, comunque, è di percezione sociale: siamo abituati a immaginare l’artista – il pittore, lo scrittore, il musicista – come a un uomo, e ogni volta che ci interfacciamo con un’artista donna lo facciamo stupiti, concentrandoci sul fatto che sia una donna, e non sull’opera d’arte in sé. Diventa celebre l’artista in quanto tale, meno il suo lavoro (il caso di Frida Kahlo è piuttosto emblematico). Nella letteratura succedeva – ma la percezione è che capiti ancora – una cosa simile. La scrittrice ha sempre avuto bisogno, agli occhi del pubblico, di una giustificazione della scrittura. Una storia personale particolarmente travagliata, una violenza subita: il lavoro veniva ricondotto, anche dai critici, a pura testimonianza. Il testo lo si pubblica, sì, ma per un motivo specifico. Quando Sibilla Aleramo scrisse Una donna, pubblicato nel 1906, la critica letteraria lo accettò e riconobbe in quanto testimonianza autobiografica e, poi, come riflessione (proto)femminista. L’autobiografia c’è, è vero, e ha un grosso peso nella genesi dell’opera, così come ci sono le riflessioni di stampo femminista, ma innanzitutto quel libro è un romanzo, un’opera d’arte! La verità, allora, è che abbiamo sempre faticato, e in un certo senso fatichiamo ancora, ad accettare che una donna possa essere un’artista, che il suo lavoro valga al di là del genere; e non è più lodevole in quanto donna, perché ci siamo anche stufati di accettare la retorica (tutta maschile) del bel lavoro compiuto da una donna. Come a dire, incredibile!, non solo è un bel lavoro, ma l’ha anche fatto una donna! E il tutto condito con le solite frasi di circostanza, appellativi ed epiteti infantilizzanti quali “la reginetta del romanzo” o simili, perché per quanto pronunciati in buona fede continuano a sminuire il lavoro della persona, che nulla ha a che vedere con il genere. Accettiamo, una volta per tutte, la possibilità di essere artiste, al di là di ogni altra implicazione, solo artiste. Artiste e basta. ENRICO PONZIO
Saperne di piùUn viaggio all’interno della fibromialgia
Il racconto di Susinaandfriends (che racchiude quello di molte altre persone) Quanto conosciamo e comprendiamo la fibromialgia? Personalmente, ne sapevo molto poco, non tanto per la sua sintomatologia, che si può conoscere facendo una rapida ricerca su Google, ma per quanto subdolamente e invisibilmente si intrufola nella vita di chi ne soffre. Così, mi ritrovo un giorno su Instagram a digitare la parola fibromialgia, e mi ritrovo davanti un account avente come immagine del profilo una simpatica susina sorridente. Dietro la susina viola (@susinaandfriends) si cela Susanna, una ragazza di 28 anni che ha deciso di parlare senza filtri della sua malattia (e non solo) e di diventare un’attivista entrando a far parte del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. Un piacevole dialogo che mi ha aperto gli occhi su un mondo che dovremmo tutti esplorare. Quando hai iniziato ad avere i primi sintomi legati alla fibromialgia? Ho iniziato ad avere i primi sintomi di quella che ora so chiamarsi fibromialgia a 19 anni circa. Mal di testa sempre più frequenti, disturbi gastrici, intolleranze alimentari, una strana stanchezza dal risveglio, un dolore senza spiegazioni alla spalla, poi al collo, poi sempre più diffuso. Sono arrivata alla diagnosi a 26 anni, dopo due anni di disturbi invalidanti e dolori ormai diffusi in tutto il corpo. Hai pensato che fosse fibromialgia anche prima della diagnosi ufficiale? Non conoscevo neanche l’esistenza di questa malattia. Ne ho sentito parlare per la prima volta nel bel mezzo di un fine settimana a base di Netflix e pisolini sul divano, quando il mio dito ha premuto play sul documentario “Gaga: five foot two” che segue la superstar Lady Gaga mentre lancia il suo nuovo album e si prepara per l’esibizione durante il Super Bowl. L’aspetto umano dell’artista è rappresentato in maniera straordinaria, lasciando intravedere anche le debolezze e le difficoltà dovute alla malattia che la affligge da anni. Stiamo ovviamente parlando della Fibromialgia. Sono bastati 10 minuti o poco più per realizzare che quella cosa che stavo vedendo sullo schermo era anche la “mia cosa”. A quel punto ho deciso di fidarmi del mio istinto e di andare da un reumatologo (anzi in realtà da un paio). È così mi sono ritrovata con in mano la diagnosi di sindrome fibromialgica scritta nero su bianco. Quali sono, secondo la tua esperienza e quella altrui, i sintomi che non bisogna sottovalutare? Il principio fondamentale, che non vale solo per la fibromialgia, è che il dolore va sempre ascoltato e indagato. Purtroppo, l’invalidazione del dolore, soprattutto delle persone assegnate femmina alla nascita, è una problematica sistemica ancora tristemente attuale. Susina, che impatto ha avuto la fibromialgia sulla tua vita e sulle tue relazioni? A livello di relazioni non ho avuto particolari difficoltà. Sicuramente in questo ha aiutato la mia predisposizione nel raccontarmi, aprirmi e confrontarmi con le altre persone. Non è sempre facile e non lo è per tutti: non essere capiti, non trovare sostegno ed empatia nelle altre persone può portare a chiudersi in sé stessi, aumentando il senso di solitudine e di esclusione dalla vita sociale ritenuta “standard”, basata sulla mitizzazione del corpo umano come macchina perfetta e valutata nella sua produttività. Mi sono scontrata anche io con questo senso di inadeguatezza rispetto a quello che la società si aspettava da me e al percorso che io stessa avevo scelto per il mio futuro. Ho dovuto mettere in discussione il mio stile di vita e adattarlo alle mie nuove esigenze, trovare un nuovo equilibrio e cambiare il percorso lavorativo che avevo intrapreso. La malattia ti ha comportato dei problemi anche dal punto di vista del ciclo mestruale? Il dolore per chi soffre di fibromialgia non è costante, oscilla nel tempo in base a condizioni esterne (ad esempio i cambi di stagioni) ma anche alle condizioni e attività della singola persona. Per questo motivo anche l’andamento del ciclo mestruale influenza il dolore che, nei giorni delle mestruazioni, diventa davvero difficile da tollerare. Come nasce il progetto Susina and friends? Quando ho ricevuto la diagnosi ho iniziato a fare ricerche nel web e mi sono accorta che la narrazione della fibromialgia era spesso vittimistica e riferita a un target di persone over 40. Così ho deciso di raccontare la malattia dal punto di vista di una ragazza di 25 anni con tanta voglia di scherzare, ridere e divertirsi con gli amici. Il racconto della malattia è utile a farla conoscere a più persone possibile ma è stato anche un atto terapeutico per me stessa, oltre ad avermi dato la possibilità di confrontarmi con molte persone nella mia stessa condizione e ritrovarmi in una meravigliosa rete di sostegno reciproco e disinteressato. Com’è avvenuto l’incontro col Comitato per la vulvodinia e la neuropatia del pudendo? Nell’ottobre del 2021, con Non Una di Meno, abbiamo portato nelle piazze italiane le testimonianze di tant3 che, come me, soffrono di malattie invisibilizzate, ovvero non riconosciute dal SSN Italiano. Si tratta di fibromialgia, endometriosi, adenomiosi, vulvodinia e neuropatia del pudendo. In questa occasione ho conosciuto alcune delle persone che adesso, insieme a me, sono parte del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, associazione che si batte per il riconoscimento di queste due malattie. Mi sono subito ritrovata nella loro determinazione e voglia di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose e ho deciso di intraprendere questo percorso di attivismo insieme a loro. Susina, pensi vi sia ancora molto pregiudizio nei confronti di questa malattia? Purtroppo, il pregiudizio su questa malattia è ancora molto presente, anche nella stessa classe medica. Il dolore è un campo di ricerca estremamente complesso, le cui dinamiche sono in gran parte sconosciute. Il dolore femminile viene normalizzato, come se le donne fossero destinate a soffrire e sopportare: anche questa è una forma di discriminazione di genere. In che modo potremmo fare per bene dell’attivismo affinché la fibromialgia venga riconosciuta come malattia invalidante? Dobbiamo fare lo sforzo di eliminare la lente abilista, la convinzione che tutte le persone siano sane e considerare «eccezione» tutte le persone che non lo sono. Dobbiamo imparare ad assumere come unico atteggiamento possibile in risposta al dolore altrui quello dell’“Io ti credo”. Dobbiamo usare la nostra voce per diffondere i messaggi di lotta altrui, sostenere le reciproche battaglie: i diritti non si dividono, non sono fette di una torta, i diritti si creano e ce ne sono per tutti. Antonella Patalano
Saperne di piùVivere il tabù mestruale
Ricordo molto bene il giorno in cui arrivarono le mie prime mestruazioni. Avevo 15 anni e tanta voglia di sentirmi, finalmente, una donna. Era una domenica, e com’ero solita a fare in questa giornata, stavo giocando un’importante partita di pallavolo. Me la cavai piuttosto bene e riuscimmo a portare a casa la vittoria. Per raccontare questa breve storia, però, dovrei partire dal contesto. E il contesto era un po’ diverso da quello che si potrebbe immaginare. Non mi sono mai sentita veramente parte della mia squadra. Di nessuna squadra. Ero timida ma verace, e in campo ero molto severa. Sia con me stessa, che con gli altri. La vittoria, per me, ha sempre simboleggiato un senso di rivalsa. In quel caso sull’avversario. Volevo vincere non per dimostrare di essere forte, ma per dimostrare a me stessa e alle avversarie che anch’io meritavo di essere in quello stesso posto. Che, in qualche modo, eravamo uguali. Che il mio impegno, anche se avessimo perso, sarebbe stato all’altezza del loro. Perché era lo stesso e identico. “Siamo comunque uguali”. Con il senno di poi, non mi è difficile capire che stavo inconsciamente cercando un posto, un luogo, una situazione della quale sentirmi fisicamente parte. La stessa cosa, infatti, accadeva già tre volte a settimana nello spogliatoio della palestra. I miei occhi vedevano costantemente le mie compagne svestite, nude, a proprio agio nel loro corpo formoso, lavarsi una accanto all’altra. Parlavano di ragazzi e di mestruazioni; si scambiavano assorbenti. Ero l’unica delle ragazze a non avere avuto ancora “il ciclo”, a non avere ancora un briciolo di seno o di forme. Ero ancora nelle sembianze di una bambina sebbene, dentro, non lo fossi affatto. Il mio corpo acerbo e il mio sviluppo ritardatario rappresentavano, ai miei occhi di ragazzina in quella fase difficile dell’adolescenza, un ostacolo verso quell’accettazione, quel senso di partecipazione e di “vittoria” sopracitato che volevo provare nei confronti delle mie compagne. Al di fuori di quella rete e di quella palla bianca, noi non eravamo affatto uguali. Nemmeno l’argomento “ragazzi” riusciva a farmi uscire dal mio guscio. Dopotutto, la mia forte timidezza e la mia bassa autostima non mi aiutavano di certo nell’approccio spesso disastroso che avevo con l’altro sesso. E, uscire allo scoperto, mi avrebbe fatto sentire giudicata. Cosa che, sicuramente, sarebbe poi accaduta. E così, lo ammetto, iniziai a mentire. Non fu affatto una cosa studiata, successe e basta. Facevo finta di avere le mestruazioni anch’io, dilettandomi nel raccontare qualche breve aneddoto che avevo sentito dire da mia sorella in giro per casa. Mentire, però, non funzionò ugualmente. Perché, arrivata a quel punto, mi sentivo molto più impostore che bambina. E quindi sì, ricordo perfettamente il giorno in cui ebbi la menarca, perché una felicità e un senso di sollievo invase tutto il mio corpo. Rimasi così, incantata e sorpresa, mentre osservavo le mutande abbassate sulle mie ginocchiere e sui miei calzettoni da partita. Toccava, finalmente, a me. Avevo vinto, ma vinto davvero. Improvvisamente, ero “diventata" una donna. Questa storia, in realtà, raccontandola a distanza di tanti anni e di tanti cicli mestruali, mi ha dato grandi spunti di riflessione. Penso al mio punto di vista, quello che vi ho appena spiegato, a quella celebrazione che è stata per me il mio ciclo mestruale e poi, però, penso a quell’alone di tabù che circonda questo evento naturale e fisiologico che investe ogni donna in età fertile e che spesso, dalla società, viene visto come qualcosa di impuro e minaccioso. Come, citando alcune frasi che ho sentito dire durante la mia vita, “qualcosa di cui non potersi fidare. Sanguina 5 giorni al mese e non muore mai”. Ricordo bene mia madre, dopo l’arrivo delle mestruazioni, rammentarmi di non dirlo assolutamente mai ad alta voce se fossi stata in “quel momento”. Ricordo gli assorbenti nascosti nelle maniche del maglione quando si chiedeva al professore il permesso di andare in bagno, oppure, attualmente, i diversi “shhhhh!” che mi tuonano le mie conoscenti quando dico a voce alta : “Ce l’hai un assorbente?”. Non sono una sociologa esperta e nemmeno una grande intellettuale. Nel corso degli anni e sopratutto crescendo, ho iniziato a notare cose che prima mi era difficile vedere. Vuoi un po’ la cultura con la quale siamo sempre stati cresciuti, vuoi un po’ la società, sua conseguenza, adagiata e creata su schemi ripetitivi e difficilmente influenzabili rispetto ai cambiamenti sociali e storici in atto. Ho sempre pensato che la donna con le mestruazioni fosse vista come una persona “fuori controllo”. Inerme, in preda a un tempesta ormonale che la rende cattiva, pericolosa, nervosa. Fragile. Come se non potesse essere in grado di controllare il proprio corpo. Come se fosse una sua scelta, un “disturbo”, una sua debolezza e non un fattore fisiologicamente normale. Come se, in quei giorni, fosse in una situazione fisica ed emotiva di cui vergognarsi, da nascondere, in grado di trasformare “la più pura e accomodante donna” in un mostro cattivo e sessualmente impuro. Sarà per questo, chissà, che durante la gravidanza, e quindi in assenza delle mestruazioni, la donna viene sempre adorata e venerata. Viene definita più bella, radiosa, più calma. Più pura. Come se, in qualche modo, potessimo essere definite così solo in quanto madri o in procinto di diventarlo. Tempo fa, inciampai in un articolo molto interessante. La giornalista, ovviamente, era una donna e riportava alcuni estratti del libro di Giuliana Sgrena “Dio odia le donne”. Riassumeva, in 5 minuti di lettura, la visione delle mestruazioni femminili secondo le religioni sparse per mondo le quali, nei secoli, hanno contribuito a rafforzare l’idea secondo cui le donne sono “colpevoli” di avere le mestruazioni andando poi così ad aumentare lo stigma femminile condannandole, appunto, all’isolamento e alla vergogna. Se ne para nel Corano, nell’Ebraismo, l’Induismo fino ad arrivare al Cristianesimo. E considerato quanto impatto abbiano ancora le religioni sulla nostra cultura, questa ricerca fa a dir poco rabbrividire tanto quanto fornisce una serie di risposte a modelli comportamentali patriarcali ormai fortemente radicati. D’altronde, qualche mese fa, quando chiesi al mio allenatore come si organizzavano le atlete femminili professioniste durante le competizioni importanti qualora avessero avuto il ciclo mestruale, davanti alla mia pura curiosità mi sentii rispondere (non da lui) : “Noi uomini, invece, siamo sempre pronti”. Come se, appunto, fosse una debolezza e una scelta, qualcosa che mi rende ancora più fragile agli occhi di una categoria di uomo, lo stesso che, per avvalorare questa tesi, è contrario al congedo mestruale. Perché: Non puoi avere “trattamenti” extra che io non posso avere. E, dato che ti lamenti, comprati pure i tuoi assorbenti (ormai beni di lusso), dato che non te li riconoscerò mai come beni essenziali. Detto questo, ho voluto iniziare questo articolo con la mia storia perché, a distanza di tempo, la porto ancora nel cuore. Per mettere in contrasto la netta differenza che vi è tra vivere le mestruazioni, nel bene e nel male, e parlare, senza sapere, di mestruazioni. Per non vederle solo come evento, ma anche come componente psicologica, senso di appartenenza. Penso che, in qualche modo, discutere liberamente di queste possa normalizzarle e contribuire alla perdita del potere negativo che le ha sempre accompagnate. Iniziando a vederle non solo come una “condizione femminile” ma come un argomento che riguarda ognuno di noi. VALENTINA DALLARI
Saperne di più