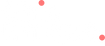Periodica Magazine: lo spazio per il dialogo aperto
Parliamo di vulvodinia
Il trattamento dalla vulvodinia è un problema sanitario, sociale ed economico irrisolto: un percorso tra disagi, falsi miti e soluzioni effettive Sono ancora fin troppe le donne, sia giovanissime che in età fertile, ma anche dopo la menopausa, che soffrono di vulvodinia e che spesso non lo sanno. Nonostante circa il 15% dell’intera popolazione femminile ne sia affetta, come descritto in svariati articoli e studi, la vulvodinia rimane ancora oggi una patologia poco conosciuta dalla classe medica e dalla società. Sono infatti innumerevoli le pazienti che, non sapendo cosa fare, si sono rivolte speranzose alle proprie ginecologhe e ai propri ginecologi per ricevere, invece, risposte come “Signorina, il suo dolore non esiste, è solo nella sua testa”, “Signora, la sua è solo una cistite, aspetti che le prescrivo un ciclo di antibiotici, ovuli e lavande” oppure qualche mirabolante rimedio senza alcun razionale clinico, insistendo con le pazienti sul fatto che fossero i medici ad avere ragione. Sono fin troppi i dottori che, rendendosi conto di non sapere, non danno la risposta che dovrebbero dare, che è soltanto una: “Io non so cosa fare per poterla aiutare, è meglio che si affidi a un* professionista più preparato di me in questa materia, io nel mentre cercherò di colmare questa mia mancanza di conoscenza.”. Purtroppo, questa ammissione è poco diffusa. Capitano fin troppo spesso, invece, episodi di invalidazione del dolore e dei sintomi, di diagnosi e di piani terapeutici completamente errati, di mancanza di capacità nel riconoscere e curare correttamente questa problematica ginecologica. Fortunatamente, grazie all’impegno di molte attiviste e di molt* professionist*, la vulvodinia sta iniziando ad avere finalmente uno spazio concreto nelle discussioni, sia a livello parlamentare, sia a livello medico ma anche nella popolazione stessa. Non è possibile, difatti, che una paziente che soffre di questa patologia ne sappia più di molti medici che dovrebbero, invece, essere in grado di aiutare questa persona e di guidarla attraverso il processo di cura e di guarigione. Secondo uno studio europeo condotto del 2019, tra il 45% e il 60% dei ginecologi non sa fare una diagnosi di vulvodinia; il 20% la conosce, ma non saprebbe trattarla: questa percentuale, nella maggior parte, si concentra nel Nord Italia. Tutto ciò causa un ritardo diagnostico di anni: alcune pazienti che attendono qualche anno, altre che hanno atteso anche tra i 12 e i 15 anni prima di ricevere una diagnosi. Le cause della mancanza di conoscenza sono molteplici: in primis la società patriarcale e maschilista per la quale un dolore come questo in passato è stato riconosciuto – e lo è ancora, purtroppo da più medici – come mentale, dunque non biologico e fisico. Non è un caso che le parole isteria e simili derivino da histerëcus, che significa utero, imputando in generale la causa delle patologie mentali alle donne. Ma ancora oggi nelle Scuole di Medicina e Chirurgia italiane, spesso patologie come la vulvodinia vengono soltanto accennate, ma non affrontata nel dettaglio come sarebbe corretto fare. Tutto questo alimenta una circolazione inesatta delle informazioni, dando spazio sia nel mondo dell’internet sia tra diversi professionisti – che di professionale hanno ben poco, verrebbe da dire – a bufale che riguardano sia le cause della vulvodinia sia i rimedi. Vediamo insieme, quindi, alcuni di questi falsi miti e quali siano, invece, le terapie corrette che vengono proposte da parte di professionisti seri e realmente preparati. Diffidate da qualsiasi professionista che vi dica che per guarire dalla vulvodinia serve avere più rapporti sessuali – in posizioni diverse e senza essere tese –; che il dolore deriva dalla paura di avere rapporti o che sia causato da una mancanza di desiderio nei confronti del proprio partner; diffidate da chi indica la causa del dolore nello stress, da chi consiglia di provare la malva, vari tipi di integratori e prodotti omeopatici oppure addirittura di usare i cristalli – sì, stiamo parlando davvero di cristalloterapia – o da chi nega il vostro dolore. Spoiler: non è normale provare dolore. Diffidate inoltre da chi consiglia di rimanere incinta, perché la gravidanza risolve tutto: non è così. O magari di concedersi all’alcol per inibire il dolore. Queste sono solo alcune delle risposte che numerose pazienti si sono sentite e si sentono tuttora riferire. La vulvodinia non si cura così! Innanzitutto, bisogna diagnosticarla correttamente e questo si fa attraverso il cotton swab test e l’anamnesi eseguita insieme alla paziente, ascoltando tutto quello che la paziente sente di condividere e di raccontare, indagando soprattutto la tipologia di dolore che prova, di come si sente durante i rapporti sessuali e al di fuori di questi, e se noti anche dei disturbi a livello intestinale. Sono molte le domande da fare per un’anamnesi accurata e appropriata: un vero professionista non si limiterà a quelle citate qui sopra, ma ne farà di ulteriori per completare la propria diagnosi differenziale di vulvodinia. È poi necessario effettuare una valutazione del tono del pavimento pelvico per comprendere lo stato di quest’ultimo: ipertono del pavimento pelvico e vulvodinia, infatti, vanno a braccetto. A queste diagnosi devono seguire sia un piano terapeutico che la riabilitazione del pavimento pelvico, la quale non può essere omessa in presenza di ipertono. La cura della vulvodinia non si basa solo su questi passaggi effettuati da un* ginecolog*, ma si deve adottare un approccio multidisciplinare che comprenda anche altr* professionist* della salute, come fisioterapist*, endocrinologh* urologh*, nutrizionist*, psicoterapeut*/psichiatr* e laureat* in Scienze Motorie e Sportive: sono davvero molte le componenti da considerare e sulle quali si può lavorare per un migliore stile di vita. Essendo varie e diverse le cause, la terapia deve essere non solo personalizzata, ma anche adattata alla sintomatologia della paziente. Per stabilire un rapporto terapeutico sano fra medico-paziente, è fondamentale: Credere alla paziente e ascoltarla; evitare di farla sentire responsabile del proprio dolore e di quello che sta affrontando; evitare di sovrastimare i benefici secondari; evitare di renderla passiva e dipendente, perché il migliore approccio è che la paziente sia la protagonista attiva del proprio processo di cura; chiedere come il dolore persiste anziché chiederne il perché; definire chiaramente obiettivi realistici verso i quali accompagnare la paziente e adattare lo stile del trattamento a quest’ultima. Ed eccoci, finalmente, al cuore di questo articolo: i vari trattamenti della vulvodinia, che sono molto differenti fra loro e attraverso i quali si cerca di ottimizzare il controllo del dolore – nella consapevolezza che una sua totale scomparsa potrebbe non essere possibile – e migliorare lo stato di benessere psicofisico e, così, la qualità di vita. Tra le terapie farmacologiche, quelle più efficaci a livello sistemico sono gli antidepressivi ciclici, gli anticonvulsivanti e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) off-label che, a dosaggi inferiori, interrompono i circuiti del dolore cronico e la sensibilità abnorme dei nervi causante l’allodinia, quella sensazione dolorosa che viene percepita senza esserci realmente un danno. Qualora il medico ritenesse opportuno prescrivere tali farmaci informerà la paziente dei possibili effetti indesiderati e concorderà con lei le modalità di assunzione. A livello locale si possono applicare anestetici topici in crema, come la lidocaina, direttamente in sede vestibolare per alleviare transitoriamente il dolore, soprattutto prima dei rapporti sessuali. Ci sono, inoltre, anche formulazioni in combinazione con antidepressivi/anticonvulsivanti per migliorarne e potenziarne l’efficacia a livello topico. È possibile utilizzare anche creme inibenti l’attività mastocitaria al fine di evitare un’iperattività dei mastociti. Queste sono a base di aliamidi, come l’adelmidrol, o di sodio cromoglicato e polidatina, elementi che impediscono la degranulazione dei mastociti. L’associazione di questi principi attivi può essere un ottimo coadiuvante nel controllo della risposta infiammatoria propria dell’innesco, del mantenimento e della riattivazione delle alterazioni neuropatiche proprie della vulvodinia. Alla terapia farmacologica viene associata la fisioterapia: ogni programma di terapia, dalla farmacologica alla manuale, fino a quella psicologica, è personalizzato in base ai risultati della valutazione iniziale della paziente. Il fisioterapista ha dei compiti fondamentali nel processo di cura: infatti, oltre alla valutazione e alla riabilitazione manuale della muscolatura specifica del pavimento pelvico e del bacino, deve effettuare una valutazione posturale e della respirazione della paziente, perché il diaframma lavora in associazione con la muscolatura del pavimento pelvico. A questa valutazione devono seguire la correzione degli atteggiamenti posturali non corretti e l’insegnamento di una good practice a cui la paziente deve attenersi, come esercizi di stretching e di detensione della muscolatura coinvolta nell’ipertono. Eventuali tensioni muscolari della zona del bacino, poi, vanno a influenzare la contrattura della muscolatura del pavimento pelvico e, dunque, sarà da agire anche su queste. Le terapie manuali effettuate con la fisioterapia e quelle fisiche, cioè attraverso l’utilizzo di macchine, se eseguite con regolarità, danno sollievo nell’80% dei casi. Una terapia fisica è quella del biofeedback elettromiografico che permette di imparare un metodo di auto-rilassamento per controllare le contrazioni dei muscoli e, di conseguenza, il dolore. La finalità della terapia è consentire alla paziente d’imparare a controllare la muscolatura pelvica, riducendo progressivamente l’ipertono che la caratterizza. Si può ricorrere, tra i trattamenti fisici, anche alla TENS (la Stimolazione Elettrica Nervosa Transcutanea), tecnica che consiste nell’applicare sulla parte interessata alcuni elettrodi che emettono impulsi elettrici a bassa frequenza in grado di inibire le afferenze nervose coinvolte nella trasmissione del dolore. Ai presidi medici e farmacologici va affiancato, poi, uno stile di vita e comportamentale volto a ridurre al minimo gli stimoli irritativi, magari utilizzando determinato abbigliamento intimo e non oppure l’utilizzo di prodotti adeguati alla cura dell’igiene intima. Un supporto psicoterapeutico può essere utile, in particolare quando in anamnesi si evidenziano elementi riferibili a traumi psicologici o di abusi fisici e/o sessuali. Nel momento in cui, però, questo tipo di soluzioni non dovessero essere sufficienti, è possibile ricorrere a dei trattamenti più invasivi, come le infiltrazioni nelle sottomucose vestibolari di cortisonico e anestetico locale, che, attraverso la rapida interruzione del sintomo, l’azione antiinfiammatoria e l’effetto inibitorio esercitato sulle fibre nervose, ne fanno un’efficace metodica. Un altro tipo di infiltrazione è quella muscolare della tossina botulinica, che agisce a livello della giunzione neuromuscolare inibendo il rilascio dell’acetilcolina e, quindi, provocando una spasmo-lisi muscolare. Anche la chirurgia, solitamente utilizzata come ultima soluzione, può essere uno strumento terapeutico per affrontare questa patologia. C’è, quindi, una serie di trattamenti differenti di cui usufruire e molti altri sono ancora in fase di studio all’interno di diversi trial clinici. Una domanda, però, sorge di fronte a tutto questo: chi è a pagare per tutte queste cure? Le pazienti, di tasca propria. Si stima che una donna, infatti, possa spendere fino a 50 mila euro nell’arco dell’intero percorso di diagnosi e di cura della vulvodinia. Le mancanze del Servizio Sanitario Nazionale hanno permesso a diversi specialisti privati, sedicenti “guru” propinatori di rimedi totalmente inefficaci, di chiedere cifre astronomiche per una prima visita o anche per una semplice valutazione del pavimento pelvico. Il prezzo, anche se viene fatta una media, rimane comunque oneroso: tra i 150 e i 250 euro per le visite ginecologiche, ogni mese almeno 300 euro di fisioterapia, tra i 50 e i 100 euro di integratori realmente efficaci e circa 50 euro di farmaci non detraibili. Senza tenere conto del costo della psicoterapia. E chi non può permettersi una spesa del genere? Purtroppo, la risposta la sappiamo. Oltre alla scarsa formazione di personale medico specializzato, la vulvodinia non è riconosciuta neanche dallo Stato: lo dimostra il fatto che la malattia non compare nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè non è una malattia per la quale sono previste prestazioni o servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma sono tutte a pagamento. La vulvodinia è e rimane, purtroppo, ancora doppiamente invisibile: al medico, che non la conosce e riconosce, e allo Stato. Le uniche a vederla sono le pazienti lasciate a soffrirne la presenza nelle proprie vite. Ed è ora che questo mantello di invisibilità venga tolto. LORENZO CIOL
Saperne di piùVulva o vagina?
Guida definitiva alle differenze fra vulva e vagina: perché le confondiamo così spesso? La differenza tra vulva e vagina è essenziale, ma per troppo tempo è stata ignorata per una sorta di “comodità” o abitudine. Usare indifferentemente il termine vagina per descrivere tutta la parte anatomica femminile è sempre stata una consuetudine, però è ovvio che non sono la stessa cosa e, con l’intento di fare chiarezza e di educare sulla sessualità e il corpo, in questo articolo analizzeremo per bene le loro differenze. Intanto, in primis, la vulva è il complesso degli organi genitali esterni femminili che, oltre all'apertura esterna della vagina, ospita il meato dell'uretra, la clitoride e alcune piccole ghiandole, il tutto delimitato dalle labbra vulvari. Al contrario, la vagina è il canale muscolare elastico interno che si estende dal collo dell'utero al vestibolo e funge da organo femminile dell’accoppiamento, è una componente del canale del parto e serve per espellere il sangue mestruale. Ma, all’interno di queste due “macro parti” esistono tante altre “micro parti” che, nell’insieme, costituiscono appunto la vulva e la vagina e che andremo a scoprire assieme. Di quali parti è composta la vulva e com’è fatta?Nel corso degli anni, rappresentazioni distorte e standard di bellezza hanno influenzato anche l'anatomia dei genitali femminili, creando idee infondate su come dovrebbero essere. Tuttavia, ogni vulva è diversa, unica: come ci piace dire a noi, non ne esistono due uguali.E non rimangono uguali. Infatti, non dobbiamo dimenticare che il suo aspetto cambia nelle varie fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa, e tutto ciò dipende dai livelli ormonali. • Il monte di Venere: formato da tessuto adiposo dal quale crescono i peli, è detto anche monte del pube ed è situato appena sopra la vulva; copre l’osso pubico e sovrasta le grandi labbra ed è delimitato dalle pieghe dell’inguine.• Le grandi labbra: iniziano dal monte di Venere e si uniscono nel perineo, a un paio di centimetri dall'ano, formando la forchetta vulvare. La funzione delle grandi labbra è quella di proteggere le strutture sottostanti, come le piccole labbra e sono dotate di ghiandole sudoripare e sebacee, oltre a terminazioni nervose e vasi sanguigni. Durante la fase dell'eccitazione sessuale le grandi labbra tendono infatti a gonfiarsi per l'aumentato afflusso sanguigno e si separano, rendendo più evidenti le piccole labbra, che aumentano di dimensione e accentuano la propria colorazione.• Le piccole labbra si trovano internamente alle grandi labbra, sono rosate, umide e prive di peli e la loro conformazione varia in maniera sensibile: possono essere infatti diverse, asimmetriche e di diverse dimensioni. A differenza delle grandi labbra, le piccole labbra non si uniscono, ma si assottigliano posteriormente e scompaiono piano piano confluendo nella parte interna delle grandi labbra.• Il glande clitorideo, cioè l’unica parte della clitoride visibile dall’esterno, a differenza del resto dell’organo, che si “nasconde" sotto la vulva. È rivestito da un involucro cutaneo detto prepuzio della clitoride (proprio come il prepuzio maschile che ricopre il glande del pene) ed è particolarmente sensibile, grazie a una ricca rete di vasi e di terminazioni nervose sensitive al suo interno. Infine, la clitoride aumenta leggermente di volume in stato di eccitazione sessuale, infatti è l’unico organo dedicato unicamente al piacere!• Il meato uretrale, ossia l’orfizio dal quale espelliamo l’urina e dal quale esce il cosiddetto squirt. • L’orifizio vaginale; ovvero l’ingresso della vagina. Di quali parti è composta la vagina e com’è fatta?• L’imene: è una membrana di tessuto connettivo simile ad un anello, che varia sensibilmente da una donna all'altra per dimensioni e spessore e viene “rotta” generalmente durante il primo rapporto sessuale, ma può accadere anche facendo sport o a seguito di traumi locali.• La fornice vaginale è una parte interna della vagina, situata nella parte più profonda e circonda completamente la cupola che forma il collo dell’utero. Insomma, vulva e vagina sono proprio due mondi completamente differenti, ma al contempo afferenti insieme a creare i nostri bellissimi e intimi genitali. A caratterizzare la nostra reale bellezza che è unica, diversa per ognunə di noi.Parlare di come siamo fattə, riscoprendo il nostro corpo nella sua bellezza, può allontanare dubbi, rimuovere stereotipi e tabù che si sono formati e si formano ancora attorno alle vagine e alle vulve, donando nuova e vera libertà a tuttə noi! MARTA BORASO
Saperne di piùTutta colpa della lingua?
In uno dei più conosciuti dizionari della lingua italiana, alla voce “donna” si può leggere: “femmina adulta dell’uomo / donna di casa, che ama la vita domestica, che sa governare una casa / moglie, donna amata, la mia donna / appellativo onorifico che si premette ai nomi di signore altolocate, per es. alla moglie del presidente della repubblica / signora, padrona / Nostra Donna, la Madonna / donna di servizio domestica … / donna cannone: donna grassissima, numero d’attrazione nelle fiere / figura del gioco delle carte: donna di picche”. Non vi stupirà, dunque, se in questo articolo parleremo di discriminazione di genere e linguistica. Del resto la differenza con la voce “uomo” è evidente: “un grand’uomo / un uomo di mondo / un uomo nuovo, una persona umile che si è fatta da sé / un uomo d’affari, manager /un uomo di legge, giurista, avvocato / l’uomo del giorno, chi in un dato momento o periodo si impone all’attenzione per l’attività che svolge, per i suoi meriti / un uomo di lettere …” La diamo spesso per scontata, ma la discriminazione linguistica tra uomo e donna può avere un impatto significativo sulla percezione e il trattamento dei generi nella società e può anche contribuire a mantenere e perpetuare disuguaglianze sociali ed economiche. PAROLE, SOLTANTO PAROLE? Seppure negli ultimi anni molte realtà editoriali si stiano impegnando per rovesciare il paradigma che vede il genere maschile predominante tra le pagine del dizionario, il traguardo per raggiungere l’uguaglianza tra i generi è ancora lontano. Questo perché storicamente il genere maschile era convenzionalmente considerato "genere neutro". Nei secoli, questa idea si diffuse anche in altre lingue europee, dove il genere maschile divenne il genere predominante in molti ambiti, tra cui quello della scrittura dei dizionari: nei dizionari italiani pubblicati fino a oggi, la maggior parte dei femminili non compaiono affatto o al massimo vengono affiancati con il riferimento al termine maschile (per esempio: “bella, femminile singolare di bello”). Tutto ciò è stato influenzato anche dal fatto che molte attività e professioni erano storicamente svolte principalmente da uomini e quindi i termini associati a queste attività erano spesso al maschile. QUESTIONI DI GENERE A rafforzare la discriminazione linguistica vi sono anche l’intenzione e l’accezione che spesso vengono attribuite da chi parla (intenzionalmente o meno) a molti termini femminili. Esempio cardine è che per decenni (e spesso ancora oggi) l’utilizzo del termine “uomini” per indicare gli esseri umani in generale invece del termine inclusivo “persone”. Eccone molti altri che fanno parte del nostro linguaggio quotidiano: "Uomo d'affari"/"donna di casa", implicano che un certo genere sia più adatto a certi ruoli o professioni rispetto all'altro. "Ragazzi" o "membri" per descrivere un gruppo di persone, che esclude implicitamente le donne. I pronomi maschili come "lui" o "il suo" per riferirsi a una persona di cui non si conosce il genere, che implica che l'interlocutore sia maschio per default. Nomi e aggettivi che implicano che un certo comportamento o tratto di personalità sia esclusivamente maschile o femminile. Ad esempio, "maschiaccio" o "effemminato" sono termini che suggeriscono che certi comportamenti o interessi siano adatti solo a uno dei due generi. Espressioni che escludono categoricamente il femminile come “solo per veri uomini”. Termini riferiti agli attributi sessuali esclusivamente maschili per definire una caratteristica caratteriale con accezione di forza e/o coraggio “tu si che hai le palle”. L'uso di espressioni che suggeriscono che la sessualità delle donne sia un aspetto primario della loro identità, mentre quella degli uomini no come "donna facile". Termini che minimizzano o negano l'esistenza di problemi o disuguaglianze che riguardano le donne come "femminismo estremo". Termini denigratori o offensivi per riferirsi a donne, come "puttana" o "troia", che implicano che le donne siano inferiori o oggetti sessuali. L'uso del maschile per riferirsi a un gruppo misto, ad esempio "gli studenti" invece di "gli studenti e le studentesse". Come se questo non bastasse esistono anche: Linguaggio corporale: in determinate circostanze alle donne viene imposto un utilizzo del linguaggio più sottomesso rispetto agli uomini, ad esempio evitando di guardare negli occhi. Linguaggio ambiguo: alle donne è stato insegnato di usare un linguaggio più morbido o ambiguo, ad esempio quando si tratta di comunicare un'opinione o di dare indicazioni. Giudizio di valore: le donne viene fatto notare il modo in cui parlando. Ad esempio se usano un tono troppo alto o troppo basso, se sono troppo assertive o troppo timide. Interruzione e monopolio della conversazione: gli uomini hanno spesso maggiori opportunità di interrompere le donne o di monopolizzare la conversazione senza che vengano ripresi per questo atteggiamento (al contrario delle donne). Uso dei titoli: le donne spesso vengono identificate dal loro status matrimoniale, ad esempio "signora" invece di "signorina", mentre gli uomini vengono identificati solo dal loro nome (come il tristemente comune: “la fidanzata di Damiano dei Maneskin” per indicare Giorgia Soleri) La differenza di tono e linguaggio: ad esempio, si possono usare parole come "forte" e "assertivo" per descrivere un uomo, ma "aggressivo" e "dominante" per descrivere una donna che ha le stesse caratteristiche. E LE PAROLACCE? Noi donne vantiamo un’invidiabile sequela di epiteti volgari a noi riferiti, ma per raccontarveli lascio la parola alla straordinaria Paola Cortellesi che recita un monologo ispirato a un testo di Stefano Bartezzaghi sugli usi sessisti della lingua italiana… VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk di EMILIA BIFANO
Saperne di piùIRRITAZIONI E PRURITO INTIMO: COSA SONO E COME PREVENIRLI
Le irritazioni intime sono un problema comune a tutte le età: a chi non è mai capitato di provare quella fastidiosa sensazione di prurito? Anche se l’argomento ci sembra delicato, è molto importante non lasciare che l’imbarazzo ci blocchi dal parlarne.In questo articolo potrai trovare le principali cause di questo problema, e alcuni consigli per prevenirlo. 1.1 Le cause delle irritazioni intime: Infezioni fungine: anche note come candidosi o micosi vaginali, le infezioni fungine sono una delle cause più comuni di prurito intimo nelle donne. Queste infezioni sono dovute alla crescita eccessiva di un fungo che si trova naturalmente nella flora vaginale, la Candida Albicans. I sintomi delle infezioni fungine includono prurito intenso nella zona vaginale e vulvare, dolori durante i rapporti sessuali, scarico vaginale biancastro e spesso. Infezioni batteriche: le principali infezioni sono la vaginosi batterica e la vaginite batterica, causate dall’eccessiva proliferazione di batteri nel canale vaginale. I sintomi delle infezioni batteriche sono molto simili a quelli delle infezioni fungine, per questo, per curarle, è molto importante consultare un medico. Cambiamenti ormonali: i cambiamenti ormonali che si verificano durante pubertà, ciclo mestruale, gravidanza e menopausa, possono alterare i livelli di secrezioni vaginali e rendere la zona intima più sensibile alle irritazioni Biancheria intima troppo attillata o sintetica: indossare biancheria intima sintetica o troppo stretta può causare un eccesso di sudorazione e creare un ambiente favorevole alle infezioni batteriche e fungine, e creare un attrito fastidioso contro la zona dei genitali. Irritanti chimici: alcuni prodotti per l’igiene intima, come i saponi antibatterici o i deodoranti vaginali possono contenere sostanze chimiche aggressive che alterano il pH della zona intima e causare irritazione e prurito Irritazioni dovuti ad assorbenti e tamponi: il prurito intimo durante le mestruazioni può essere causato da molti fattori, tra cui materiali sintetici come il poliestere e il rayon, profumazioni che mascherano l’odore ma irritano la zona della vulva, reazioni allergiche ai materiali di cui sono composti assorbenti e tamponi, e infine durata troppo prolungata dell’uso. 1.2 Come prevenire le irritazioni intime: Mantenere una buona igiene intima: lavarsi con acqua tiepida e sapone neutro, evitare di utilizzare detergenti intimi profumati, e asciugarsi bene dopo la doccia Indossare biancheria intima in materiali traspiranti come il cotone, che aiuta a prevenire la sudorazione e la crescita di batteri Tutelare il sistema immunitario: mantenere una dieta sana ed equilibrata, fare esercizio fisico e dormire regolarmente può aiutare a rinforzare le difese immunitarie e a prevenire le infezioni Utilizzare assorbenti e tamponi in cotone: soprattutto durante il periodo delle mestruazioni, è meglio preferire assorbenti in cotone, ipoallergenici e non profumati, per evitare infezioni e fastidiosi pruriti.This Unique (link) è un assorbente ipoallergenico composto al 100% da cotone organico, che non contiene deodoranti, né polveri assorbenti che inquinano l’ambiente e irritano la pelle. In sintesi, le irritazioni intime sono un problema molto comune che può derivare da molti fattori e possono essere fastidiose per molte donne. Tuttavia, ci sono soluzioni che possono aiutare ad affrontare questo problema. In caso di irritazioni intime persistenti o gravi è molto importante consultare un medico per escludere eventuali infezioni. Prurito intimo: perchè gli assorbenti giusti possono migliorarti la vita. Il prurito intimo è un problema molto comune, un taboo che spesso le donne si trovano ad affrontare da sole. Uno dei momenti in cui questo problema si manifesta più frequentemente è durante le mestruazioni: in questa fase, infatti, non è raro doversi confrontare con pruriti che rendono l’esperienza molto spiacevole. In questo articolo ti spiegheremo perchè utilizzare i giusti prodotti mestruali può risolvere (quasi tutti) i tuoi fastidi intimi: Perchè sento pruriti intimi durante le mestruazioni? Durante il ciclo mestruale, il corpo subisce numerosi cambiamenti ormonali che possono causare secchezza vaginale e irritazione della pelle intorno all’area genitale, causando pruriti. La causa maggiore dei pruriti intimi, però, è l’utilizzo di assorbenti e tamponi standard: Qual è la differenza tra assorbenti standard e assorbenti in cotone organico? I prodotti mestruali standard che siamo abituat* ad acquistare al supermercato sono spesso realizzati con materiali sintetici, come polimeri e plastica, per garantire una maggiore assorbenza. Tuttavia, questi materiali sintetici, possono contenere sostanze chimiche irritanti che possono causare irritazioni e allergie alla pelle. Gli assorbenti in cotone organico, d’altra parte, sono realizzati in cotone coltivato senza l’uso di pesticidi o prodotti chimici o sintetici. Inoltre, la lavorazione del cotone organico è completamente naturale , e non prevede lo sbiancamento con il cloro, evitando l’esposizione a sostanze nocive e rendendolo ipoallergenico. La sudorazione causata dalla plastica, poi, crea un ambiente umido che favorisce la proliferazione di infezioni batteriche e fungine. Per questo motivo è consigliabile preferire assorbenti composti da materiali naturali e traspiranti. Ma la plastica, purtroppo, non è l’unica sostanza irritante che si trova nei classici assorbenti da supermercato: spesso, infatti, per migliorare l’assorbenza e camuffare l’odore del sangue mestruale, vengono utilizzati deodoranti e polveri assorbenti denominate SAP (Super Absorbent Powders), che aumentano il rischio di irritazioni e reazioni allergiche. Per mantenerti al sicuro dai pruriti e dalle irritazioni, ti consigliamo This Unique, l’assorbente in 100% cotone organico morbidissimo, senza polveri assorbenti né plastica, nel rispetto del pianeta e della tua intimità. Attenzione: usare assorbenti in cotone non elimina del tutto il rischio di irritazioni e infezioni: bisogna evitare di indossare lo stesso assorbente troppo a lungo e cercare di cambiarlo regolarmente, per mantenere la zona intima al sicuro da umidità e batteri.
Saperne di piùMALE GAZE (lo sguardo maschile al mondo)
Ogni volta in cui provo a spiegare a un uomo i numerosi significati che troviamo nell’essere donna in una società di stampo patriarcale, sento sempre sbuffare, vedo tanti occhi al cielo, sento diverse risatine e vengo immediatamente accusata di essere “così esagerata”. Il tema di cui vorrei parlare oggi è quello che cerco di spiegare agli uomini che mi circondano, sentendo di avere il compito di donargli un punto di vista che non possono conoscere e con il quale non hanno mai avuto a che fare nonostante, questa società di stampo patriarcale, in qualche modo, vada indirettamente a colpire anche loro stessi. Ho letto tantissime cose riguardo al “male gaze” ovvero allo “sguardo maschile”, di come abbia influito moltissimo nella definizione popolare del “ruolo” ( e dell’aspetto ideale) della donna nella nostra società e di come abbia indirettamente influito anche sull’uomo stesso, andando a stimolare in esso l’imitazione continua di un modello tossico fino alla formazione, ovviamente, di una cultura nociva vera e propria. Per “sguardo maschile”, quindi, non s’intende soltanto uno sguardo sessualizzante, ma s’intende anche la genesi di questo modello culturale che affonda le proprie radici nella narrazione, nell’unico punto di vista maschile (non neutro) attraverso il quale il mondo è sempre stato abituato a vedere. Lo troviamo nel cinema, da dove ho scoperto nasce proprio questo nome “male gaze”, nella televisione e anche, ovviamente, nella vita quotidiana. Una delle cose che mi viene più difficile è spiegare a un uomo che cosa significa questo sguardo per noi donne e di come sia stato difficile accorgersi, crescendo, di come questa subdola manipolazione abbia effettivamente creato inconsciamente una convinzione radicata in noi donne (e con effetti sulla cultura) per la quale il nostro valore fosse solo giudicabile tramite quello sguardo (quindi un punto di vista) maschile e tramite le sensazioni ed emozioni scatenate in questi ultimi con l’inconscia convinzione, fin dalla nascita, che il nostro ruolo fosse solamente legato al puro e semplice scopo di appagare, sostenere, accomodare e di conseguenza farsi accettare, farsi definire ed eventualmente farsi scegliere da questo “uomo protagonista”. Come se dovessimo anche essere “degne” di essere scelte. Svegliarsi è come ricevere una mattonata in faccia, una doccia fredda tramite la quale prendere atto della quantità di luoghi/situazioni/sistemi e comportamenti tossici di cui siamo sempre state circondate, e di come essi vengano socialmente giustificati e considerati “normali” e, di conseguenza, messi in atto meccanicamente dalla società con lo scopo di andare a rimarcare questo “male gaze” che noi donne, purtroppo, abbiamo saldamente scolpito dentro di noi. (Non è una colpa, crescere in un ambiente così ci ha portate ad avere questo sguardo/pinto di vista dentro di noi). Chiaramente, questo sguardo, questa narrazione maschile, ha dato un significato al corpo della donna posizionandola non solo come soggetto dipendente dall’uomo ma, di conseguenza, anche come oggetto sessuale con l’unico scopo di soddisfare le pulsioni del maschio eterosessuale. Un corpo, in pratica, di proprietà dell’altro, facente parte di una donna senza alcun sentimento, desiderio o controllo. Da qui, potremmo collegarci tranquillamente anche al significato vero e proprio del problema del “Cat Calling”, di come l’uomo si senta in diritto (spinto da quello che viene schifosamente giustificato come istinto animale) di osservare e commentare il corpo della donna e di come lei, di conseguenza, non possa ribellarsi e di cui, secondo loro, dovrebbe sentirsi compiaciuta per il valore sessuale e quindi sociale dell’attenzione che lui ci sta REGALANDO. In fin dei conti, secondo questo sguardo maschile, il valore di una donna è direttamente proporzionale alla sua desiderabilità, alla sua bellezza e al desiderio sessuale che essa è in grado di smuovere nell’uomo (tramite il proprio corpo). Essere guardate e di bell’aspetto è infatti qualcosa che ci viene inculcato fin dalla tenera età e da cui, nel mio parere, ne deriva anche una parte di causa della famosa “competizione femminile” come se, inconsciamente, facessimo a gara tra di noi per ricevere le attenzioni (capaci di farci sentire importanti e valorose) del narratore della nostra storia lasciandogli il potere e il controllo di incasellarci/indicarci un ruolo (chiaramente sbagliato) che, in realtà, per colpa di questa società di stampo patriarcale, la donna fatica a trovare da sola. Se ci pensiamo, infatti, nella nostra società la donna considerata “valorosa” e “degna di attenzioni” viene sempre dipinta come una persona passiva, accomodante, dipendente dall’uomo, amorevole, bisognosa d’aiuto e, perchè no, anche futura madre (spoiler, anche le religioni hanno messo un bel carico). Inutile dire che questo, infatti, influisca letteralmente sul modo in cui noi donne percepiamo noi stesse ( e le altre) sia fisicamente ma anche nella comprensione della nostra funzione nella società. Questa continua oggettificazione della donna porta inevitabilmente ad annullare la persona, ad annullare la sua identità e il suo reale ruolo nel mondo e, di conseguenza, smuove nel soggetto colpito un’insicurezza riguardo alle sue capacità professionali, un’insicurezza e senso di estraneità con il proprio corpo e una vergogna, un senso di colpa riguardo alla propria presenza fisica. Io stessa, avendo sempre lavorato in ambienti maschili, sono stata spesso accusata di lavorare solo grazie alla mia bellezza o, allo stesso tempo, sono stata sminuita professionalmente tramite allusioni al mio corpo o, di recente, rimproverata per non aver usato il mio corpo per ottenere più rilevanza lavorativa. Non a caso, con il senno di poi, credo che in qualche modo il mio disturbo alimentare sia stato anche un modo di inconscia (è una malattia) ribellione riguardo allo sguardo sessualizzante dell’uomo e, purtroppo, lo sguardo invidioso delle donne che ho incontrato nella mia vita. Quell’invidia nata, come dicevamo precedentemente, da una massiccia quantità di sguardi maschili che ho sempre ricevuto nel corso della mia vita e che sono sempre stati decifrati erroneamente, dalle altre donne, come metro sociale, come se io fossi appunto più “valorosa” di loro. In un modo o nell’altro, da entrambe le parti, il mio ruolo veniva sempre ridotto unicamente alla mia presenza fisica, senza che io fossi mai davvero, realmente, ascoltata / vista come una persona. Questo continuo rifiuto a livello umano che ho sempre subito (non voglio fare la vittima, ma questa è la realtà) da parte di entrambi i sessi e del mio rifiuto di essere definita donna secondo la definizione maschilista e non quella reale, credo abbia sicuramente influito molto nell’aspetto psicologico e profondo del mio disturbo alimentare e quindi, di conseguenza, al mio rifiuto nell’ avere un corpo che fosse considerato desiderabile sessualmente/eccitante dagli uomini, che fosse considerato oggetto di invidia dalle donne e, infine, che fosse considerato ingombrante dalla sottoscritta, e che andasse a minare la mia credibilità lavorativa. Questa introduzione lunghissima che ho scritto l’ho fatta perchè chiunque leggesse questo articolo potesse in qualche modo calarsi lentamente in un punto di vista femminile, per arrivare quindi a empatizzare con un argomento che purtroppo oggi viene spesso deformato, banalizzato e, purtroppo, non considerato veritiero da una certa fetta di popolazione maschile (non tutta) e, ahimè, femminile. Credo che nel 2023 sia doveroso informarsi, sia in qualità di donne che anche in qualità di uomini, abbracciando l’idea che un nuovo tipo di cultura possa renderci persone elevate e migliori, cittadini di un mondo che rispetta i diritti umani delle donne e che si presta a considerarci tutti uguali, senza essere vittime di discriminazioni, divari di genere e stereotipi di genere. Sperando di essere sempre di più, a far rumore, a scardinare, a unire le forze, per lottare contro una società e, di conseguenza, una cultura che ha sempre fatto di tutto per non ascoltarci. VALENTINA DALLARI
Saperne di piùRadical chic senza radical
Che la rivoluzione che ci sforziamo di portare avanti accolga dentro di sé numerose esigenze - le lotte di genere, l’ambiente, le ingiustizie sociali, il razzismo - è un fatto riconosciuto: diversə attivistə o influencer (spesso le due categorie si accavallano) si impegnano in ambiti differenti e distanti in nome, anche, dell’intersezionalità. Tutto ciò, pensiamo, è positivo: non possiamo relegare ogni singola lotta a un misero individualismo, senza alcuna possibilità di dialogo o incontro. Si parla di tanto, è vero, e perciò capita talvolta che gli argomenti vengano appena sorvolati, sfiorati e poi lasciati da parte per passare al prossimo, impellente come qualunque altro. Ci si batte, sì, con impegno, ma non sempre con la necessaria profondità o preparazione, non sempre con le armi adatte. È ad ogni modo un problema facilmente risolvibile: compito dellə attivistə o influencer non è scavare nel dettaglio dei problemi, ma sollevarli. Che se ne parli è già di per sé un traguardo - soprattutto se pensiamo a certe minoranze, dimenticate oltre che discriminate - ed è un traguardo ancora maggiore il fatto che la gente ascolti. Forse a causa della velocità dei mezzi di informazione o forse per una maggiore sensibilità delle nuove generazioni, l’espansione mediatica di certi dibattiti è notevole rispetto a pochi anni fa, quando tali discorsi erano relegati ai più intimi circoli. La gente ascolta, dunque, legge, parla. E inesorabilmente, come sempre quando si è sulla bocca di tuttə, giungono le critiche. Uno dei cavalli di battaglia di coloro che, infatiditə da queste lotte, vi si oppongono fermamente, è l’accusa di buonismo. Termine vago, in effetti, e piuttosto vuoto, che però può essere sintetizzato con un concetto più specifico, quello di radical chic. Chi è attento ai problemi degli ultimi, chi si batte per l’uguaglianza di genere o si schiera dalla parte dei migranti è, sempre e comunque, un radical chic. Nel dibattito pubblico italiano, tale espressione viene utilizzata - pare - con una frequenza sempre maggiore, e quasi sempre in senso dispregiativo. Il termine è composto da due parole, una inglese e una francese, che indicano rispettivamente una tendenza radicale (appunto) e di sinistra, e un senso di raffinatezza e di moda - chic. Spulciando l’Oxford Dictionary leggiamo che si tratta, in poche parole, dell’ostentazione, molto di moda, di idee radicali e di sinistra. Non solo. Oltre al suo valore estetico, il termine chic sembra implicare un senso di agiatezza economica. Insomma, di ricchezza. Radical chic sarebbe quindi chi, ricco e forse annoiato, si diletta in battaglie sociali dall’alto della sua posizione di privilegiato. L’accusa, se ci pensiamo bene, è proprio quella. Il problema (forse meglio dire uno dei) della sinistra è proprio quello di relegarsi in circoli ristretti, intellettuali o pseudo intellettuali e borghesi, e da questa prospettiva giudicare, proporre, criticare. Ed ecco che in questo modo, negli anni, i suoi consensi sono non solo sprofondati, ma hanno cambiato bacino, nutrendosi di quei pochi laureati, spesso figli di laureati, che forse ancora la ascoltano. E allo stesso tempo sembra non esserci la volontà, da parte della sinistra, di dialogare con il popolo (esiste ancora questo concetto?). E così ci si allontana dalla realtà, le battaglie diventano chiacchiere, e si diventa radical chic. Ora, le lotte di cui parlavamo e nelle quali crediamo fortemente, pur essendo lotte politiche non sono sempre condivise o discusse dalla politica. Sono attivistiə e personaggi pubblici che si battono quotidianamente per far sì che questi argomenti vengano portati alla luce. Tuttavia, e questo è il punto, capita che anche queste discussioni, queste lotte di cui noi stessə facciamo parte, limitino il loro pubblico a una manciata di persone. O meglio: a una categoria sociale specifica, che ancora una volta è composta da giovane laureatə che hanno tutti gli strumenti - neanche sempre - per comprendere il focus della lotta. Il discorso spesso rimane chiuso, limitato a quellə di noi che leggono certi articoli, che seguono le riflessioni di certə attivistə, e che complicano il discorso ripiegandolo su se stesso, ogni giorno di più, senza accorgersi che al di fuori c’è un mondo che non l’ha capito, né vuole seguirlo. L’impressione è che a volte commettiamo il vecchio peccato della sinistra, quello di spaccarsi in microgruppi interni, litigiosi o anche soltanto eccessivamente retorici, che perdono il punto di vista, l’obiettivo. La lotta che portiamo avanti - le battaglie di genere, sociali, antirazziste eccetera - è giusta, senza dubbio. Ma è un’operazione inutile continuare a ripetercelo a noi stessə come a farci i complimenti da solə, è inutile crogiolarci nella consapevolezza di avere ragione puntando il dito contro chiunque non la pensi come noi, tacciandolə come poverə ignorantə. Combattiamo contro questo nuovo pregiudizio che ci pesa sulle spalle, riprendiamoci tutte quelle persone che una laurea non ce l’hanno, che non conoscono l’articolo, o l’attisìvista o l’influencer: convinciamo loro che abbiamo ragione! Che ciò per cui ci battiamo è giusto, che è utile per tuttə, ma facciamolo con umiltà, con ascolto, con il dialogo. Non releghiamoci nei circoli e nei salotti, reali o virtuali che siano. Perché altrimenti, alla fine, diventeremo davvero radical chic. Sì, ma senza radical.
Saperne di piùAnche gli uomini mestruano
Mestruazioni e luoghi pubblici, quando si è transgender: la storia di Elia Bonci tw: disforia, mestruazioni, discriminazione Qualche mese fa ho scoperto un bar col bagno gender neutral. La cosa mi ha sorpreso molto, anche perché vi era una simpatica vignetta che rappresentava un uomo, una donna e un alieno. Alieno, etimologicamente parlando, significa altro. Un altro che, in realtà, nessuno dovrebbe essere costretto a dover rivelare. Come sappiamo, invece, nei bagni pubblici, regna ancora sovrano il binarismo uomo-donna, costringendo le persone ad outing forzati. Pur essendo una persona cisgender, ho compreso in quel momento quanto un posto possa diventare inclusivo, sicuro ed accogliente con pochi e semplici accorgimenti. Infatti in quel bar ci torno sempre volentieri. Per questo motivo, per l’intervista di questo mese ho deciso di contattare Elia Bonci, scrittore e attivista lgbtqia+, autore di tre libri: Diphylleia. Solo l'amore può distruggere l'omofobia;Distruttori di felicità e, infine, Controcuore. Non avere paura di essere chi sei. Da anni sul suo profilo Instagram @elia.lien si batte per sensibilizzare le persone sul tema dell’omofobia e ogni tipo di discriminazione. Inoltre, rende il pubblico partecipe del suo percorso gender affirming e delle peripezie che bisogna affrontare prima di ricevere i nuovi documenti d’identità e accettarsi per quello che si è. Elia, come hai vissuto l’arrivo del menarca? Ho vissuto quel momento come fosse una vera e propria tragedia, che solo a ripensarci mi viene un nodo alla gola. Non avevo informazioni su di me, non avevo gli strumenti adatti per comprendere cosa stesse succedendo al mio corpo e per quale motivo quello che accadeva mi faceva sentire così sbagliato, sporco e inadeguato. Non avevo neanche idea di chi fossero le persone transgender e che, anche io, lo ero. Le informazioni che mi mancavano per comprendermi e conoscermi hanno finito per ferirmi, lasciando spazio a stereotipi, falsi miti e tanto altro. Qual è stata la tua esperienza con i bagni pubblici? Ècambiata nel tempo? Credo che i bagni pubblici siano per me un po’ come quando arrivi alla fine di un videogioco e devi sconfiggere il mostro finale: un’impresa. Andare in bagno in un luogo pubblico ha sempre rappresentato un problema sia perché non esistono (ora ne esistono un po’) bagni neutri sia perché i bagni degli uomini non sono inclusivi e sicuri. Quando devo andare in un bagno pubblico è sempre la solita storia: se entro nel bagno delle donne vengo cacciato e mi viene detto che quello non è il mio bagno, se entro nel bagno degli uomini vengo guardato male, ricevo battutine e non mi sento al sicuro. Oltretutto, nel bagno degli uomini non ci sono mai cestini per gettare assorbenti, confezioni di assorbenti per l’occorrenza e spesso in alcuni ci sono solo orinatoi che, come puoi ben immaginare, sono un problema concreto per una persona trans che deve andare semplicemente in bagno. Si potrebbe risolvere il tutto creando bagni neutri ma forse siamo ancora lontani da questo traguardo. Come ricordi l’acquisto degli assorbenti al supermercato? Anche qui, la situazione che si viene a creare è molto imbarazzante. Spesso gli assorbenti si trovano nel reparto dell’igiene intima femminile, accanto a prodotti di bellezza o comunque su scaffali in cui c’è scritto a caratteri cubitali ‘prodotti per donne’. Questo non è per niente inclusivo, ti fa sentire sporco, sbagliato e inadeguato. Anche le indicazioni sopra alle stesse confezioni dei prodotti sono tutte al femminile, come lo sono le immagini, gli spot e le pubblicità. Le persone transgender non vengono solo escluse dall’immaginario collettivo quando si parla di mestruazioni ma anche dal dibattito che vi si crea intorno, rendendo poco accessibili prodotti per l’igiene personale e per la cura. Ricordi qualche episodio in cui ti sei sentito particolarmente a disagio, quando avevi le mestruazioni? Tutta l’adolescenza. Avere le mestruazioni, essere un ragazzino transgender e non avere gli strumenti per comunicare il mio dolore è stato terribile. Non uscivo di casa, non volevo andare a scuola, ho smesso di fare sport. Privarmi delle cose era l’unico strumento che avevo per cercare di non sentirmi così a disagio. Alla luce del tuo percorso gender affirming, che dura da diversi anni, com’è il rapporto col tuo corpo ora? Il percorso gender affirming mi ha cambiato e salvato la vita. Se prima odiavo il mio corpo, se prima lo ritenevo sbagliato, ora ho imparato a farci la pace. Ho capito che non devo cambiarlo, gettarlo, sostituirlo o distruggerlo. Questo è il mio corpo, è il mezzo tramite il quale sono e vivo il mondo. E non ha niente che non va e niente che lo renda una schifezza, è un corpo come un altro e merita amore, rispetto e cura. Il percorso gender affirming mi ha insegnato a prendermi cura anche delle cose che non mi piacciono di me. Cosa pensi si debba fare per rendere le mestruazioni più inclusive? Come prima cosa, credo sia importante includere nel personetransgender nel dibattito sulle mestruazioni. E per includere non intendo fare spot pubblicitari in cui compaiono (che potrebbe anche andar bene) ma farci parlare e smetterla di parlare al posto nostro. È arrivato il momento di chiedere a noi personetransgender di cosa abbiamo bisogno e non che qualcuno lo decida a priori per noi, basandosi su falsi stereotipi e falsa rappresentanza. Altra cosa che ritengo importante, oltre alla creazione di bagni neutri, è quella di creare prodotti per l’igiene mestruale anch’essi neutri, che non siano tutti al femminile e non escludano nessunə. Infine, non perché di meno importanza, credo che dobbiamo modificare il nostro linguaggio quando parliamo di mestruazioni: non donne che mestruano ma persone con le mestruazioni, non prodotti per l’igiene femminile ma prodotti per l’igiene mestruale e così via. ANTONELLA PATALANO
Saperne di piùVulvodinia e sessualità
Come vivere l’intimità senza dolore Come sappiamo, la vulvodinia è una malattia ginecologica caratterizzata da dolore cronico a carico della vulva e dei tessuti che circondano l'accesso alla vagina, classificata come una condizione invalidante che colpisce più aspetti della vita quotidiana: dalle cistiti ricorrenti, le sensazioni di bruciore, irritazione, secchezza e tensione, all’impossibilità di sedersi, di indossare vestiti stretti, fino alla dispareunia, conosciuta anche come “dolore da rapporto sessuale”. Meno colloquialmente possiamo dire che, con il termine dispareunia, si intende il dolore genitale che si verifica durante il rapporto, e si distingue in superficiale (in sede di penetrazione con dolore urente all’introito vaginale), e profondo (in sede vaginale profonda e nello scavo pelvico). Esso si scatena nella maggior parte di casi in concomitanza con i tentativi di penetrazione, anche se può insorgere ed essere avvertito anche durante o dopo il coito: una condizione che rende difficoltoso vivere appieno l’esperienza senza timori o sensazioni spiacevoli e che risulta essere uno dei principali ostacoli al vivere il piacere sessuale. Di conseguenza, anche il modo stesso di vivere la sessualità, per chi è affettə da vulvodinia, cambia e si differenzia rispetto a quello normalmente (o potremmo dire solamente maggiormente, perché chi definisce cos’è normale o meno per ognunə di noi?) conosciuto. Una delle sfide più importanti che spesso ci si trova ad affrontare è quella di “accantonare” momentaneamente o per sempre (il tutto in base alla propria volontà, alle proprie scelte personali e al proprio monitoraggio del dolore) una parte del sesso per com’è sempre stato vissuto e per come ci è stato imposto dalla società: una società fallocentrica che ci ha spintə a pensare per troppo tempo che il fulcro del rapporto sessuale fosse necessariamente la penetrazione e, che senza di essa, per chi ha un apparato genitale femminile, fosse impossibile godere a pieno. Ovviamente queste affermazioni sono profondamente false: esistono vari modi di vivere la sessualità che non sono legati all’esclusivo atto della penetrazione e che possono essere delle validissime alternative per personə con vulvodinia. Non solo: il mito della penetrazione come unico modo di avere un rapporto sessuale non è l’unico scoglio da superare. È essenziale anche trovare una persona che comprenda il vostro personale modo di vivere la sessualità, rispetti quelli che sono i vostri bisogni e limiti: è importante infatti non sottovalutare mai il disagio fisico che si prova e fermarsi qualora si dovesse sentire dolore. Quali sono dunque le soluzioni alternative per essere intimi e praticare dell’attività erotica che non includa la penetrazione sessuale? Dry humping: ossia lo sfregamento dei propri genitali (o una parte del corpo) contro i genitali e il corpo del proprio partner (potete scegliere di sfregare il clitoride contro il suo pene così come tra le sue cosce o altre zone erogene). Si può fare con i vestiti addosso oppure senza e permette di vivere l’intimità secondo le proprie regole: sarete infatti voi a decidere come e quanto spingervi e muovervi sul partner, gestendovi personalmente in base al dolore. Masturbazione reciproca: masturbarsi a vicenda può essere estremamente sensuale e non comprende necessariamente la penetrazione. Basterà lasciare che il partner tocchi la vulva (clitoride, labbra) senza entrare nella vagina mentre voi masturberete lui - magari guardandosi negli occhi o parlandosi per rendere il tutto più intimo. Masturbare sè stessi mentre si guarda il parthner: questa tecnica lascia ancora più liberə di toccarsi secondo le proprie regole e/o bisogni (è utile soprattutto quando si conosce da poco il partner, che non è totalmente a conoscenza dei nostri limiti/sta ancora imparando, oppure nei momenti in cui si è più sensibili). Tribadismo: detta anche sforbiciata - per la posizione a forbice che la caratterizza - è una tecnica che prevede lo sfregamento di due vulve, per stimolarsi vicendevolmente il clitoride. Fellatio: praticare del sesso orale al proprio partner stimolandolo tramite la bocca è un modo per far eccitare l’altra persona e auto eccitarsi guardandolo. Potete scegliere di concentrarvi esclusivamente sulle sue espressioni di piacere e sui suoi movimenti oppure al contempo sfregarvi sul suo corpo con la vulva stimolando il clitoride. Cunnilingus: è considerata una delle pratiche sessuali che più riescono a dare piacere a una donna e farla arrivare all’orgasmo, di conseguenza può essere una delle alternative più apprezzate alla penetrazione. In più, siccome per le personə affette da vulvodinia è molto importante la lubrificazione, è una delle tecniche che più la stimolano, mischiando fluidi vaginali a saliva. Se non ve la sentite di essere penetrate con la lingua, basterà concentrarsi sul resto della vulva e sul clitoride. Sex toys: al giorno d’oggi esistono tantissimi sex toys progettati per essere usati solo esternamente. Basta pensare ai succhia clitoride a pulsazioni, vibratori esterni che vibrano da capo a piedi - perfetti per essere applicati anche sul perineo o sui capezzoli e in qualsiasi altra zona preferiate - fino ai plug anali. Da usare sia quando siete solə che in coppia! Massaggio erotico: divertimento per tutto il corpo! Farsi toccare, accarezzare e sfregare una ad una le zone erogene fino ad arrivare lentamente e gradualmente, tenendoci sulle spine, alla vulva. MARTA BORASO
Saperne di piùMENTE E CORPO (in conversazione con Sblam Italia)
Mente e corpo sono inseparabili: non esiste l'una senza l'altro. Quando il benessere della mente si crea e si rafforza allora riverbera nel corpo. Quando il corpo sta bene la mente può migliorare liberamente. Questo avviene perché la mente e il corpo sono coinquilini, è quindi importante imparare a prendersi cura di tutto il pacchetto. Ascoltati: che cosa dice la tua testa? Che cosa dice la tua pancia? Cominciamo a pensare a questo. La testa è il tuo ragionamento razionale, il pensiero cognitivo, mentre la pancia è il tuo istinto, la voce del tuo corpo, la bussola emotiva. Se la pancia suona l'allarme rosso qualcosa non va. Cominciando ad ascoltarti e ad avere consapevolezza dei segnali puoi imparare aessere gentile con te e con il tuo corpo, tappa fondamentale nel percorso verso ilbenessere mentale. Mostra gratitudine e apprezzamento per il tuo corpo, non per il suo aspetto, ma per tutti processi che sostiene ogni giorno e che ti mantengono in vita e in salute (i polmoni che trasformano l’ossigeno in anidride carbonica, il cuore che pompa il sangue nelle vene, gli occhi che ti consentono di vedere, le gambe che ti permettono di muoverti...). Cerca di riconnetterti con i segnali del tuo corpo: questo può voler dire che a voltepreferirai riposarti e recuperare le energie piuttosto che andare in palestra, ma può anche voler dire che altre volte troverai il tempo di uscire per andare a correre perché sai che è ciò di cui il tuo corpo ha bisogno in quel momento. Chiediti (e cerca di rispondere) che cosa ami del tuo corpo. Cerca di non concentrarti solo sugli aspetti estetici e prendi in considerazione anche gli aspetti funzionali e pratici del tuo corpo. Pensa a tutto ciò che il tuo corpo ti permette di fare ogni giorno. Potrebbe anche solo essere camminare, respirare o digerire il cibo che mangi! Queste cose possono sembrare di importanza relativa, ma sono fondamentali per mantenerti in vita, felice e in salute. Chiediti (e cerca di rispondere) quali siano le cose del tuo corpo per cui sei grat*. Il tuo corpo fa molto per te: ogni giorno ti permette di muoverti attraverso la vita e sperimentare tutto ciò che ha da offrire, non importa quanto tu sia in forma, o che cosa pensi del tuo aspetto. Rispettare il tuo corpo significa trattarlo con dignità e con l’intenzione di soddisfare i suoi bisogni. Apprezzare il tuo corpo è il primo passo di un percorso che ti porta a sviluppare una connessione più profonda con te stess*. Certo, non è sempre facile: la società in cui viviamo tende a premiare l’aspetto fisico con canoni molto rigidi e privilegia i corpi che si conformano a un modello ideale. Questi messaggi vengono pesantemente rinforzati da televisione, social media, riviste, settore della moda, pubblicità alimentari e in generale dalla cultura pop. Ricordati, però, che il rispetto per il tuo corpo viene da dentro e non riguardal’aspetto fisico. È un atteggiamento incondizionatamente positivo nei confronti della tua umanità e di te stesso o te stessa in quanto persona. La dignità e il rispetto sono diritti umani e non dipendono dalla taglia del tuo corpo, ma prevedono che tu abbia cura di esso. Avere rispetto per il proprio corpo significa anche accettare la propria genetica. E imparare ad apprezzarsi. Parti da un presupposto: non tutto è modificabile. Ci sono alcune parti di te che sono lavorabili e altre che devi imparare ad accettare, sei un essere umano quindi avere dei limiti è parte stessa della tua esistenza. Il confronto con il limite e l’accettazione dello stesso sono inevitabili passaggi verso il vero amor di te. E quando parliamo di accettazione non descriviamo un processo disottomissione o di rassegnazione. L’accettazione non porta alla passività di fronte ai sentimenti spiacevoli e dolorosi, ma prende atto che esistano e ti consente di viverli senza soccombere, per diventare più forte. Lavora sulla tua immagine corporea interna. L'immagine corporea risponde sostanzialmente alla domanda: "Come ti vedi quando ti guardi allo specchio o quando ti immagini nella tua mente?". In senso più ampio, include anche le sensazioni che hai riguardo agli aspetti del tuo corpo che dipendono principalmente dalla genetica e non sono sotto il tuo controllo e include anche il come percepisci e controlli il tuo corpo quando ti muovi o ti trovi in situazioni sociali. Tieni presente che l'immagine corporea non è limitata soltanto all’immagine fisica del tuo corpo ma include anche le tue opinioni sul tuo aspetto (compresi i tuoi ricordi, le cose che dai per scontate e le generalizzazioni, ad esempio il modo in cui ti vedi quando guardi delle tue foto). Le persone con un'immagine corporea negativa hanno una maggiore probabilità di sviluppare un disturbo alimentare e hanno maggiori probabilità di soffrire di depressione, isolamento, bassa autostima e di sviluppare ossessioni per la perdita di peso. Un’immagine corporea negativa può manifestarsi in questi modi:● Avere una percezione distorta delle tue forme: percepisci alcune parti del tuo corpo diversamente da come sono realmente.● Sentirti a disagio nel tuo corpo.● Credere che solo le altre persone siano attraenti e che la taglia o la forma del tuo corpo siano praticamente fallimento personale. Vergognarti, provare ansia e imbarazzo per il tuo corpo. Un’immagine corporea positiva invece è: ● Avere una percezione chiara e reale della tua figura, che ti permetta di vederele varie parti del tuo corpo per come sono realmente.● Sentirti a tuo agio e sicur* di te nel tuo corpo.● Sentirti fier* e accettare il tuo corpo per come è pur non ritenendolo perfetto.● Apprezzare la tua forma fisica e credere che l'aspetto fisico dica poco sul carattere e sul valore di una persona. Capita a tutt* di avere “giorni no”, in cui ci sentiamo a disagio nei nostri corpi, ma la chiave per sviluppare un'immagine corporea positiva è esplorarti, conoscerti, accettarti e valorizzarti. E puoi imparare a fare tutto questo!
Saperne di più