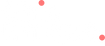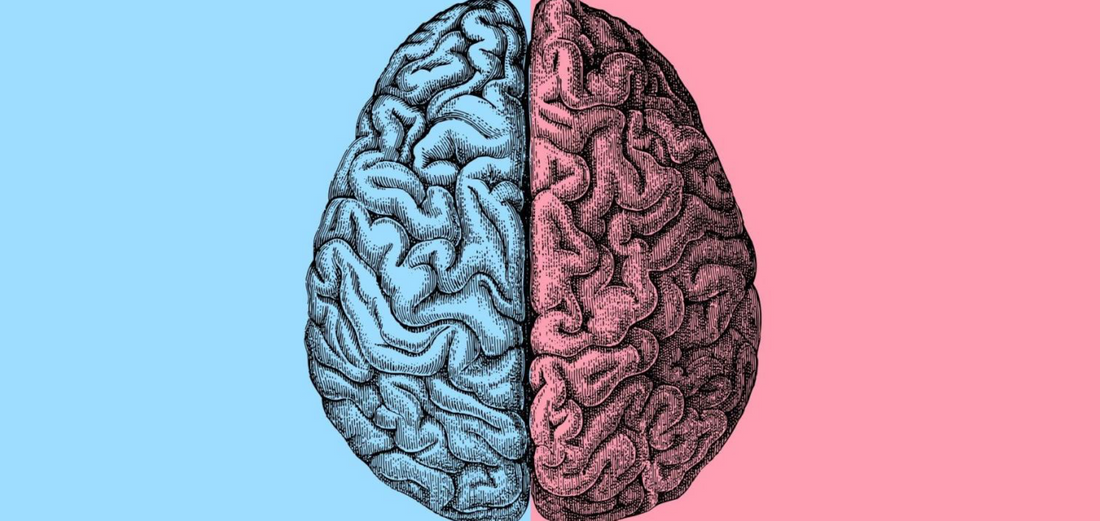Periodica Magazine: lo spazio per il dialogo aperto
Perché con l’assorbente interno il ciclo sembra finire prima?
Molte persone notano che usando un assorbente interno il ciclo sembra finire prima. In realtà non è così: il tampone non accorcia il ciclo, ma trattiene internamente il flusso, riducendo la percezione delle perdite. Negli ultimi giorni, quando il flusso è minimo, questa differenza è ancora più evidente. È importante ricordare che la durata biologica delle mestruazioni non cambia e che l’uso dei tamponi richiede sempre attenzione e rispetto delle regole di sicurezza.
Saperne di piùLa Candida: un’intrusa silenziosa che tuttə dovremmo conoscere
Tutti i giorni ognunə di noi convive con miliardi di microrganismi: alcuni amici fedeli, altri, invece, possono diventare degli ospiti davvero indesiderati. La Candida, infatti, si distingue per la sua subdola capacità di trasformarsi da coinquilina innocua a fastidioso nemico, portando scompiglio non solo nella nostra flora intestinale, ma in gran parte del nostro organismo. Che cos’è la Candida? La Candida è un lievito, un fungo unicellulare normalmente presente sulla pelle, a livello della mucosa orale e genitale e nel tratto gastrointestinale. La specie più comune è la Candida albicans, ma esistono anche C. glabrata, C. krusei e la temibile C. auris, emergente e spesso multiresistente agli antifungini standard. Finché questo patogeno rimane in equilibrio con il resto del microbiota – cioè l’insieme dei microrganismi presenti dentro di noi - non provoca alcun fastidio. Quando, però, qualcosa rompe questa armonia, come antibiotici, diete squilibrate o stress, ecco che la Candida si può trasformare in un invasore capace di provocare diversi problemi, dando origine alla candidosi. La candidosi è solo femminile? Quando si parla di Candida, molti pensano automaticamente a un disturbo “da donne”. La realtà è, però, un’altra: anche gli uomini possono sviluppare candidosi e questo non di rado. Nel pene si manifesta in particolare a livello del glande, da cui il termine balanite da Candida o balanopostite se coinvolge anche il prepuzio. Quali sono i fattori di rischio e le cause dello sviluppo di una candidosi? La candidosi insorge quando la Candida trova condizioni favorevoli per moltiplicarsi e superare le difese del sistema immunitario e del microbiota. I principali fattori che ne favoriscono lo sviluppo includono: Sistema immunitario compromesso, a causa di condizioni quali: HIV/AIDS; trapianti d’organo; malattie croniche che rendono più vulnerabili all’infezione. Assunzione di farmaci, che alterano l’equilibrio del microbiota, eliminando i “microrganismi amici” e favorendo la crescita di Candida come: antibiotici a largo spettro; corticosteroidi; farmaci antitumorali. Condizioni metaboliche, come: diabete non controllato (soprattutto), che crea un ambiente zuccherino favorevole al fungo; gravidanza; uso di contraccettivi ormonali. Ambiente locale caldo-umido nelle pieghe cutanee, come inguine, ascelle, sotto il seno o nell’area genitale, soprattutto con indumenti sintetici o troppo aderenti, le quali costituiscono un terreno fertile per l’infezione. Abitudini e igiene scorrette, che possono alterare il microbiota locale e predisporre alla candidosi. Tra queste: detergenti aggressivi; eccessiva pulizia intima; rapporti sessuali non protetti (possibile trasmissione partner-to-partner). Fasce di età vulnerabili, poiché presentano difese immunitarie meno efficienti: neonati (mughetto, dermatite da pannolino); anziani. Manifestazioni cliniche causate dalla Candida Le forme di candidosi si suddividono per sede e sintomi, tra le quali si riscontrano: Mucocutanee, come: Mughetto orale: placche biancastre e dolorose su lingua e gengive, spesso nei neonati o nei soggetti immunocompromessi; Candidosi cutanea: eritemi, desquamazioni e prurito nelle pieghe (inguine, ascelle), favorite da caldo e umidità. Genito-urinarie, come quelle: Vaginali: prurito intenso, arrossamento, perdite dense e biancastre (pH < 4,5) e odore sgradevole; Peniene: arrossamento del glande e/o del prepuzio con bruciore, fastidio durante i rapporti o la minzione, comparsa di placche biancastre o secrezioni dense (tipo “ricotta”) e odore sgradevole; Uretriti/cistiti: meno frequenti, ma possibili se la flora batterica è compromessa. Sistemiche, come: Candidemia: febbre, shock settico e insufficienza d’organo in pazienti critici. Diagnosi e terapia Un semplice tampone (orale, vaginale o penieno), emoculture in caso di sospetta infezione sistemica e, per casi cutanei, esame diretto con idrossido di potassio su raschiati cutanei possono confermare la diagnosi, permettendo di affrontare il problema con la strategia giusta. In genere, per trattare la candidosi, si ricorre a: Antifungini topici: creme, pomate, ovuli o collutori per forme localizzate. Antifungini orali: fluconazolo e itraconazolo, usati quando l’infezione è estesa o ricorrente. Antifungini endovenosi (echinocandine, amfotericina B) per le candidosi sistemiche gravi. Prevenzione ed equilibrio La miglior strategia contro la candidosi è non arrivare all’infezione, ma rafforzare le proprie difese naturali attraverso: Alimentazione bilanciata: Limitare zuccheri raffinati e carboidrati fermentabili (i cosiddetti FODMAP); Assumere regolarmente frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre. Probiotici e fermenti lattici Yogurt e kefir non zuccherati, crauti crudi e integratori a base di Lactobacillus e Bifidobacterium; Favoriscono un microbiota sano che “tiene a bada” la Candida. Igiene e abbigliamento Evitare saponi aggressivi che alterano il pH; Lavare i genitali quotidianamente con acqua e saponi delicati, asciugando bene; Proteggersi durante i rapporti sessuali con il preservativo; Utilizzare tessuti traspiranti (cotone, lino), specialmente in estate o durante l’attività sportiva. Gestione dello stress Lo stress cronico innalza il cortisolo, abbassando le difese immunitarie. Pratiche di rilassamento (yoga, meditazione, passeggiate all’aria aperta) aiutano a mantenere l’equilibrio. Uno sguardo di salute globale Negli ultimi anni, la Candida — quella che molti ancora liquidano come una “sciocchezza da donne” — ha iniziato a mostrare il suo volto più serio e insidioso. Non parliamo solo della classica candida vaginale o orale, ma soprattutto delle forme invasive, quelle più difficili da trattare e, in certi casi, potenzialmente fatali. Ceppi come Candida auris si stanno diffondendo con velocità inquietante in tutto il mondo, colonizzando ospedali, pazienti fragili, terapie intensive, con dati allarmanti provenienti da Stati Uniti, Europa e anche dall’Italia. E no, non è un’esagerazione: l’abuso di antibiotici, l’aumento dei pazienti immunodepressi, la pressione selettiva di antifungini usati con leggerezza hanno creato il terreno perfetto. In tutto questo, la candida ha smesso di essere "solo un fungo", diventando una minaccia sanitaria su scala globale. Serve, quindi, cambiare prospettiva. Non basta più trattare: bisogna prevenire, educare, osservare con più attenzione il nostro equilibrio interno. Significa usare gli antibiotici con coscienza, proteggendo con dieta, probiotici e stili di vita equilibrati il microbiota (che è molto più di “batteri buoni”), ascoltare il proprio corpo e spegnere quei luoghi comuni che ci fanno pensare che certe infezioni siano “colpa nostra”. La candida non è un tabù, né una colpa: è un indicatore, una spia accesa sul nostro sistema immunitario, sul nostro stile di vita e — perché no — su un mondo medico che deve ancora imparare a guardare il corpo come un ecosistema e non come un insieme di organi separati. LORENZO CIOL
Saperne di piùCistite post-sesso: perché succede e come prevenirla (davvero)
La cistite dopo i rapporti sessuali è un disturbo frequente ma poco discusso. In questo articolo scopriamo perché succede, come prevenirla con abitudini semplici (senza sensi di colpa) e quali rimedi naturali possono aiutare davvero. Se ne soffri spesso, non sei sola: conoscere il problema è il primo passo per risolverlo.
Saperne di piùCistite: cause, sintomi e come prevenirla in modo naturale
La cistite è un disturbo intimo molto comune, ma spesso sottovalutato. In questo articolo scopriamo le cause più frequenti, i sintomi da riconoscere e i rimedi naturali più efficaci per prevenirla, incluso l’integratore Cystin, pensato per il benessere quotidiano delle vie urinarie.
Saperne di piùIl cervello femminile esiste?
Neuroscienze, bias culturali e altri miti duri a morire Introduzione “Le donne sono più emotive, gli uomini più razionali.” Quante volte abbiamo sentito queste affermazioni? Ma cosa c'è di scientifico dietro queste generalizzazioni? Le neuroscienze contemporanee offrono una prospettiva diversa, smontando i miti sul cervello “femminile” e rivelando come i bias culturali influenzino la nostra comprensione dell'identità. Cervelli diversi o stereotipi travestiti da scienza? Per decenni, la ricerca neuroscientifica ha cercato di identificare differenze significative tra cervelli “maschili” e “femminili”. Tuttavia, una svolta importante è arrivata con uno studio del 2015 pubblicato su PNAS, che ha analizzato oltre 1.400 cervelli umani e concluso che la maggior parte presenta una configurazione “mosaico” di tratti, alcuni più comuni nei maschi, altri nelle femmine, ma nessuno completamente univoco (https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1509654112). E non si tratta di un caso isolato o superato. La ricerca scientifica successiva va decisamente nella stessa direzione. Studi pubblicati tra il 2021 e il 2024 continuano a smentire l’idea di due cervelli distinti. Una meta-analisi ha dimostrato che le differenze strutturali tra cervelli di sesso diverso si ridimensionano una volta controllate le dimensioni cerebrali totali (https://neurosciencenews.com/). Altri lavori, come quello pubblicato su Nature Communications, sottolineano come le configurazioni cerebrali “androgine” – che sfuggono alla logica binaria – siano associate a migliori indicatori di benessere emotivo e cognitivo (PMC). In breve: il consenso scientifico si sta muovendo in modo netto verso una visione più fluida, complessa e non deterministica del cervello umano. Parlare di “cervello femminile” oggi non è solo riduttivo: è scientificamente sbagliato. Bias culturali: quando la scienza conferma gli stereotipi Il termine bias si riferisce a un pregiudizio sistematico che può influenzare la raccolta e l'interpretazione dei dati. Nelle neuroscienze, i bias culturali possono portare a interpretazioni distorte dei risultati, confermando stereotipi di genere preesistenti. Gina Rippon, neuroscienziata cognitiva, ha coniato il termine “neurosexism” per descrivere l'uso improprio della neuroscienza per giustificare differenze di genere non supportate da dati scientifici solidi (en.wikipedia.org). L’identità: un costrutto dinamico e relazionale L'identità di genere non è determinata esclusivamente dalla biologia. È un costrutto complesso che emerge dall'interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali. Le aspettative culturali, l'educazione e le esperienze personali giocano un ruolo cruciale nella formazione dell'identità. Come sottolinea Rippon, “le esperienze guidano l'architettura del nostro cervello” (time.com). Ciò significa che l'ambiente in cui cresciamo e le interazioni sociali influenzano profondamente lo sviluppo del nostro cervello e, di conseguenza, la nostra identità. Conseguenze pratiche: oltre i miti per una società più equa Attribuire differenze comportamentali o cognitive a presunte differenze cerebrali innate tra i sessi può giustificare disuguaglianze e limitare le opportunità. È fondamentale riconoscere che molte delle differenze osservate sono il risultato di influenze culturali e sociali, non di determinismi biologici. Ad esempio, la sottorappresentazione delle donne nelle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) è spesso attribuita a differenze innate, ma studi dimostrano che le aspettative culturali e le opportunità educative giocano un ruolo più significativo. Conclusione Il concetto di un “cervello femminile” distinto da quello maschile è più un mito che una realtà scientifica. Le neuroscienze moderne ci invitano a superare queste semplificazioni e a riconoscere la complessità dell'identità umana. Riflettiamo: quali convinzioni abbiamo interiorizzato riguardo alle differenze di genere? E come possiamo contribuire a una comprensione più accurata e inclusiva dell'identità? Nota: Per approfondire, si consiglia la lettura di “The Gendered Brain” di Gina Rippon e “Delusions of Gender” di Cordelia Fine. LUCIA SCARANO
Saperne di piùSonno e mestruazioni
Lo sapevi che il tuo ciclo mestruale potrebbe metterci lo zampino anche nella qualità del tuo sonno? Ebbene sì, non bastava il mal di pancia, la voglia di carboidrati, le montagne russe emotive e quel brufolo che arriva sempre nei momenti meno opportuni... ci si mette pure il sonno a fare i capricci! Alcuni studi made in USA l (sì, quelli dove fanno anche i pancake a colazione e le ricerche su tutto!) hanno dimostrato che esiste un legame tra disturbi del sonno e ciclo mestruale. Il colpevole? Le fluttuazioni ormonali che avvengono proprio in quei giorni: estrogeni e progesterone giocano a fare i DJ e remixano il ritmo del nostro sonno. Risultato? Sonno più leggero, interrotto, o peggio… la he classica notte in bianco mentre nella testa passa il replay di ogni conversazione imbarazzante degli ultimi 10 anni. E questo, inevitabilmente, influisce sul nostro umore, sulla capacità di concentrazione, sull’irritabilità (che già non è al minimo storico), e sulla reattività agli stimoli esterni (tipo la collega che mastica forte o il partner che respira troppo vicino). Ma attenzione! Essere consapevoli di questi cambiamenti non significa farsi travolgere o pensare che il ciclo debba diventare una condanna mensile. Anzi! Comprendere come funzioniamo ci dà il potere di prenderci più cura di noi stesse. Magari durante quei giorni possiamo organizzare la giornata con un po’ più di gentilezza, scegliere attività meno stressanti, trovare dei rituali serali che concilino il sonno (no, non sto parlando di scrollare TikTok fino alle 2), e accogliere il nostro corpo per quello che è: ciclico, complesso, meraviglioso. In fondo, non possiamo fermare le onde ormonali... ma possiamo imparare a surfarle. STELLA BRUGNETTA
Saperne di piùFitness e mestruazioni: come allenarsi in base al proprio ciclo mestruale
Chi ha detto che durante il ciclo si debba necessariamente stare a casa, stesə sul divano con una borsa dell'acqua calda e una tisana rilassante?Se si sente il bisogno di rilassarsi, ben venga, ma nulla vieta di fare attività fisica anche in quei giorni. Ciclo mestruale e attività fisica Il ciclo mestruale è un aspetto fondamentale della fisiologia femminile che può influenzare vari aspetti della vita quotidiana, compresa l'attività fisica.Le donne possono sperimentare variazioni significative nella loro energia, nello stato d’animo e nelle prestazioni fisiche in base alla fase del ciclo mestruale. Allenarsi durante il ciclo può portare benefici come il miglioramento dell'umore e la riduzione dei sintomi premestruali.È possibile adattare l'allenamento alle diverse fasi del ciclo per ottenere i migliori risultati. Mestruazioni (Giorni 1-5) Durante questa fase molte donne, a causa della caduta dei livelli di estrogeni e progesterone, sperimentano crampi, stanchezza e disagio.Tuttavia, l’attività fisica leggera può ridurre il dolore e migliorare l’umore. Meglio evitare gli allenamenti ad alta intensità, preferendo camminate, yoga, pilates o stretching. Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, il movimento leggero durante la fase mestruale può contribuire a ridurre il dolore mestruale (Daley, 2009). Fase follicolare (Giorni 6-14) Questa fase è caratterizzata da un aumento degli estrogeni, che favorisce l’energia e la costruzione muscolare.Ideale per sollevamento pesi e HIIT. Uno studio del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostra che l'aumento degli estrogeni migliora il recupero e riduce il cortisolo (Sakamaki et al., 2018). Allenarsi intensamente in questa fase massimizza le capacità anaboliche del corpo. Ovulazione (Giorni 15-17) È il momento in cui l’ovulo viene rilasciato: estrogeni e ormone luteinizzante sono al picco, portando più forza e resistenza. Ideale per sessioni intense o competizioni sportive.Attenzione: l’aumento degli estrogeni può rendere le articolazioni più vulnerabili agli infortuni. Studi indicano che livelli elevati di estrogeni possono aumentare la lassità dei legamenti, favorendo infortuni come distorsioni o lesioni al ginocchio (Shultz & Dragoo, 2013). Fase luteale (Giorni 18-28) Il progesterone aumenta, preparando l’utero a una possibile gravidanza.L’energia cala, e si possono avvertire sintomi premestruali come irritabilità e affaticamento. Consigliati: yoga, pilates, esercizi a bassa intensità. Uno studio sul Journal of Sports Sciences evidenzia che il recupero attivo è più efficace in questa fase (Vaiksaar et al., 2011). Ridurre l’intensità aiuta a prevenire il sovraccarico fisico e mentale. Massimizzare l’allenamento durante il ciclo Monitora il ciclo: usa app o diario per tracciare sintomi ed energia. Pianifica con criterio: sfrutta i picchi energetici nella fase follicolare e ovulatoria. Ascolta il tuo corpo: adatta gli allenamenti al tuo stato fisico e mentale. Considerazioni finali Integrare la consapevolezza del ciclo nella pianificazione dell’allenamento può migliorare le prestazioni e il benessere generale.Le fluttuazioni ormonali non sono un ostacolo, ma un’opportunità per ottimizzare la propria routine di fitness. Con un approccio informato e flessibile, ogni donna può trovare il giusto equilibrio tra allenamento e salute personale. LORENZO CIOL
Saperne di piùInfezioni vaginali ricorrenti
Le infezioni vaginali ricorrenti, tra le quali cistiti, candidosi e vaginosi batterica, colpiscono un gran numero di donne e rappresentano una sfida significativa per la salute quotidiana femminile in tutto il mondo, soprattutto nei paesi meno sviluppati, in cui le condizioni igieniche spesso vengono meno e sono determinanti. Queste patologie non solo comportano disagio fisico, ma spesso causano anche stress e frustrazione, influenzando negativamente la qualità della vita. È cruciale analizzare e distinguere i sintomi, identificare le cause principali e adottare strategie di prevenzione e trattamento, supportate da evidenze scientifiche, per affrontare efficacemente queste problematiche, riducendone la frequenza e migliorando la qualità della vita. Cistite: una delle infezioni urinarie più comuni La cistite è un'infezione del tratto urinario (UTI) che colpisce la vescica, solitamente causata da batteri intestinali, in particolare Escherichia coli, che migrano verso il tratto urinario. Le donne sono più frequentemente colpite a causa della loro anatomia, con una breve distanza tra uretra, vagina e ano che facilita la diffusione dei batteri nella vescica. Secondo uno studio di Foxman et al. (2022), circa il 50-60% delle donne sperimenta almeno un episodio di cistite nella vita, con molte che soffrono di infezioni ricorrenti. Sintomi della cistite Dolore e bruciore durante la minzione Bisogno frequente e urgente di urinare Dolore pelvico Presenza di sangue nelle urine (in alcuni casi) La cistite ricorrente può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, rendendo essenziale comprenderne la prevenzione e la gestione. Trattamento della cistite Le linee guida attuali, come quelle pubblicate dal National Institute for Health and Care Excellence (NICE), raccomandano l'uso di antibiotici (es. nitrofurantoina o trimetoprim) per il trattamento delle UTI. È essenziale completare il ciclo di antibiotici prescritto per evitare recidive e resistenza batterica. Prevenzione e comportamenti raccomandati Urinare subito dopo il rapporto sessuale può ridurre la colonizzazione batterica nella vescica (Hooton et al., 2022) Evitare l'uso di spermicidi e diaframmi, che aumentano il rischio di cistite (Stapleton, 2023) Assunzione di probiotici contenenti Lactobacillus per mantenere l'equilibrio della flora vaginale (Kramer et al., 2024) Idratazione adeguata per aiutare a espellere i batteri Candidosi vaginale: una proliferazione fungina comune La candidosi vaginale è causata dalla crescita eccessiva di Candida albicans, un fungo normalmente presente nella flora vaginale. Fattori scatenanti: stress, squilibri ormonali, uso di antibiotici, diabete non controllato, dieta non equilibrata. Sintomi della candidosi Prurito intenso Bruciore Perdite vaginali bianche Arrossamento della zona vulvare Dolore durante i rapporti sessuali Trattamento della candidosi vaginale Secondo l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), è consigliato l'uso di antifungini topici (clotrimazolo o miconazolo). Per forme recidivanti: trattamenti prolungati con antimicotici sistemici o terapia di mantenimento. Prevenzione e comportamenti raccomandati Limitare l'uso di antibiotici Assumere probiotici durante e dopo la terapia antibiotica (Falagas et al., 2023) Indossare biancheria intima in cotone, evitare indumenti sintetici Mantenere una buona igiene intima Vaginosi batterica: squilibrio della flora batterica La vaginosi batterica si verifica quando diminuiscono i lattobacilli e aumentano batteri patogeni come Gardnerella vaginalis. Sintomi della vaginosi batterica Secrezioni grigio-biancastre Odore sgradevole (simile al "pesce marcio") Spesso asintomatica, ma può aumentare il rischio di altre infezioni. Trattamento della vaginosi batterica Secondo il CDC, si usano antibiotici come metronidazolo o clindamicina. Ripristinare la flora vaginale con gel vaginali a base di Lactobacillus rhamnosus è consigliato. Prevenzione e comportamenti raccomandati Evitare lavaggi vaginali interni Usare detergenti intimi delicati, senza profumi Usare preservativi e fare controlli regolari (Koumans et al., 2022) Antibiotico-resistenza e approccio diagnostico L'abuso di antibiotici ha contribuito a un aumento della resistenza batterica, complicando la gestione delle infezioni. È fondamentale un corretto iter diagnostico: Anamnesi completa Esami di laboratorio (es. coltura delle urine) Test diagnostici rapidi (tamponi, test pH, microscopici) Educazione del paziente sui rischi dell'automedicazione Approccio integrato per prevenire le infezioni vaginali ricorrenti Igiene intima corretta, evitando detergenti aggressivi Alimentazione equilibrata ricca di fibre e probiotici Gestione dello stress tramite yoga, mindfulness e riposo adeguato Quando consultare unə medicə? Se le infezioni sono frequenti o non rispondono alle misure preventive, è bene rivolgersi a un professionista. Potrebbero nascondere altre condizioni di salute o necessitare di trattamenti specifici. Conclusioni Le infezioni vaginali ricorrenti sono una problematica comune ma gestibile. Ogni donna è diversa e può richiedere approcci personalizzati. Un mix di consapevolezza, prevenzione, probiotici e igiene intima corretta può fare la differenza. Inoltre, queste condizioni impattano anche l'aspetto emotivo: il benessere psicologico e la qualità della vita non vanno trascurati. Parlarne è il primo passo per affrontarle, senza tabù e senza sensi di colpa.LORENZO CIOL
Saperne di piùAlimentazione e ciclo mestruale: una guida pratica e semplice
Quando parliamo il ciclo mestruale, non possiamo non menzionare come l’alimentazione possa influenzare il benessere personale durante le diverse fasi del ciclo. Un'alimentazione consapevole non solo può alleviare i sintomi del ciclo, ma può anche migliorare lo stato d'animo e la quantità di energia percepita. Ogni fase presenta cambiamenti ormonali che influenzano il corpo e la mente, rendendo fondamentale un approccio nutrizionale mirato. In questa guida esploreremo come adattare la propria dieta per supportare il corpo in ogni fase del ciclo mestruale, fornendo suggerimenti pratici e informazioni utili. Mestruazioni (Giorni 1-5) Durante questa fase, viene eliminato lo strato più superficiale dell’endometrio e si verifica la classica perdita di sangue. Questo può portare a sintomi come affaticamento, crampi, dolori e sbalzi d'umore. È fondamentale, quindi, fornire al proprio corpo nutrienti essenziali per sostenere il benessere fisico e mentale. Cosa mangiare? Alimenti ricchi di ferro: durante il ciclo, con il sanguinamento, si perde ferro, dunque è importante reintegrarlo. Fonti ottimali includono carne magra, come manzo e pollo, pesce, legumi, come lenticchie e fagioli, verdure a foglia verde, come spinaci e bietole, e semi di zucca (Mireles et al., 2019). Abbinare questi alimenti con fonti di vitamina C, come agrumi o peperoni, può migliorare l'assorbimento del ferro. Cibi ricchi di magnesio, possono aiutare a ridurre i crampi mestruali. Banane, noci, semi di girasole e cioccolato fondente ne sono ottime fonti (Wang et al., 2016). Cibi fermentati, come yogurt, kefir e kombucha, promuovono la salute intestinale, riducendo le possibilità di infezioni da lieviti, e possono migliorare l'umore grazie alla connessione intestino-cervello (Gibson et al., 2017). Mantenere un'adeguata idratazione (almeno 2 litri) è cruciale, infatti aiuta a migliorare la concentrazione e a mantenere alti i livelli di energia, oltre a ridurre l’eventualità di cefalea da disidratazione, uno dei sintomi in cui si può incorrere durante le mestruazioni. Bere acqua, tisane a base di erbe e assumere alimenti come anguria e cetriolo possono alleviare il gonfiore e migliorare l'umore (González-Muñoz et al., 2021). Cosa evitare? Cibi salati, ricchi di sodio, insaccati e formaggi possono contribuire al gonfiore, alla ritenzione idrica e all'irritabilità, peggiorando il discomfort (He et al., 2013). Cibi zuccherati possono portare a picchi glicemici seguiti da crolli di energia, aumentando la sensazione di affaticamento. Uno studio ha evidenziato che l'assunzione elevata di zuccheri semplici può essere associata a umore instabile e ansia (Benton et al., 2009). Fase follicolare (Giorni 6-14) Durante questo periodo, i livelli di estrogeni iniziano a salire, portando a un aumento dell'energia e della vitalità. Il corpo è più ricettivo ai nutrienti e alla salute generale. Cosa mangiare? Proteine magre, come pollo, pesce, uova e legumi, sostengono la produzione di ormoni e forniscono energia (Coyle et al., 2020). Frutta e verdura, ricche di antiossidanti, vitamine, fibre e sali minerali, possono aiutare a ridurre l'infiammazione e a migliorare l'umore (Boeckner et al., 2017). Acidi grassi omega-3, poiché sono particolarmente benefici per la salute ormonale. Includere avocado, noci, semi di lino e pesce grasso (come salmone e sgombro) nella dieta può aiutare a ridurre l'infiammazione e migliorare l'umore. Cereali integrali, come quinoa e riso integrale, ricchi di fibre, stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue e forniscono energia a lungo termine (Liu et al., 2018). Cosa evitare? L’alcol, infatti, può alterare i livelli ormonali e influenzare negativamente il sonno e l'umore. Ricerche hanno dimostrato che il consumo eccessivo di alcol è associato a squilibri ormonali e a una maggiore vulnerabilità ai sintomi premestruali (Mäkelä et al., 2016). Cibi fritti, spesso ricchi di grassi trans e saturi, possono aumentare l'infiammazione e influenzare negativamente i livelli di energia e la salute mentale (Mozaffarian et al., 2006). Ovulazione (Giorni 15-17) L'ovulazione è il momento culminante del ciclo mestruale, quando un ovulo viene rilasciato dall'ovaio. Durante questa fase molte ragazze possono sperimentare un picco di energia e una maggiore libido. È importante sfruttare questo periodo favorevole con una dieta ideale per prendersi cura di sé stesse. Cosa mangiare? Proteine magre, come pollo, pesce, uova e legumi, sostengono la produzione di ormoni e forniscono energia (Coyle et al., 2020). Alimenti ricchi di omega-3: pesce grasso, come salmone e sgombro, semi di lino e noci supportano l’equilibrio ormonale e possono migliorare l’umore (Bistrian et al., 2015). Cibi ricchi di zinco: questo è importante per la salute ormonale e può essere trovato in alimenti come semi di zucca, legumi e noci. Integrare questi alimenti nella dieta può supportare la funzione immunitaria durante questo periodo. Alimenti ricchi di antiossidanti, come noci, verdure colorate, frutti di bosco, fragole e kiwi, ricchi anche di vitamine e minerali essenziali, aiutando a rinforzare il sistema immunitario combattendo lo stress ossidativo nel corpo. Questi alimenti, poi, possono contribuire a una pelle sana e a una buona salute riproduttiva. (Chun et al., 2021). Cosa evitare? Cibi elaborati, che spesso contengono additivi e conservanti che possono influenzare negativamente la salute intestinale e l'umore. La presenza di ingredienti artificiali è stata associata a disordini gastrointestinali e a una peggiore salute mentale (Benton, 2010). Cibi con alti contenuti di zucchero possono provocare fluttuazioni dei livelli di energia e influenzare negativamente l'umore (Fisher et al., 2019). Fase luteale (Giorni 18-28) Dopo l'ovulazione, il corpo entra nella fase luteale, gli estrogeni iniziano a calare, mentre i livelli di progesterone aumentano. Questa fase può portare a voglie alimentari e sintomi premestruali, come gonfiore, irritabilità e crampi, ed è fondamentale adottare strategie nutrizionali per alleviare questi sintomi. Cosa mangiare? Alimenti ricchi di fibre, come legumi, verdure a foglia verde e cereali integrali, supportano la digestione e possono aiutare a ridurre il gonfiore (Slavin, 2013). Alimenti ricchi di magnesio, attraverso le sue proprietà rilassanti, possono aiutare a ridurre i crampi mestruali. Cioccolato fondente, banane, semi di girasole e spinaci ne sono ottime fonti. Cibi dalle proprietà antinfiammatorie, come curcuma, zenzero e tè verde, possono aiutare a combattere l'infiammazione nel corpo. Alimenti ricchi di omega-3, come noci, mandorle e semi di Chia, forniscono grassi sani e proteine, utili per stabilizzare l'umore e l'energia (Dreher et al., 2018). Cibi integrali e complessi, come patate dolci, avena, quinoa e riso integrale, aiutano a mantenere i livelli di energia stabili e possono alleviare le voglie di zucchero (Pérez-Jiménez et al., 2010). Cosa evitare? Zuccheri raffinati: limitando dolci e carboidrati semplici, infatti, si può aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue ed evitare picchi glicemici che possono influenzare negativamente l'umore, aumentando irritabilità e voglie alimentari (Duncan et al., 2012). Caffeina, che può aumentare l'ansia e la sensibilità agli sbalzi d'umore. Un’assunzione elevata di caffeina può aggravare i sintomi premestruali, aumentando l'irritabilità e l'insonnia (Smith et al., 2013). Consigli generali Oltre a seguire una dieta equilibrata in base alle fasi del ciclo mestruale, ci sono alcuni consigli generali che possono migliorare il benessere complessivo: Ascoltare il proprio corpo, poiché ogni donna è unica: è importante, quindi, prestare attenzione a come certi alimenti ci fanno sentire e a cosa proviamo in quel preciso momento, adattando la propria alimentazione di conseguenza. Mantenere un diario alimentare: annotare ciò che si mangia e come ci si sente durante le diverse fasi del ciclo. Questo aiuterà a identificare cosa funziona meglio per il proprio corpo. Prendersi cura di sé stessi, cercando di includere attività fisica regolare e pratiche di rilassamento, mindfulness e gestione dello stress, come lo yoga o la meditazione, per sostenere il proprio benessere generale (Rogers et al., 2016). Sonno sufficiente, infatti un buon riposo notturno è essenziale per il recupero fisico e mentale. Stabilendo una routine del sonno regolare è possibile garantire un riposo adeguato. Conclusione L'alimentazione, quindi, può avere un impatto significativo sul modo in cui ci si sente durante il ciclo mestruale. Seguendo questi consigli e adattando la dieta alle diverse fasi, è possibile migliorare il proprio benessere fisico e mentale. Bisogna ricordare che il corpo merita di essere trattato con cura e attenzione in ogni fase del ciclo. Fare delle scelte alimentari consapevoli, dunque, fa effettivamente la differenza! LORENZO CIOL Riferimenti Bistrian, B. R., et al. (2015). The role of omega-3 fatty acids in the health of women. Journal of Women's Health, 24(6), 509-516. Boeckner, L., et al. (2017). The role of antioxidants in women’s health: implications for dietary recommendations. Nutrition Reviews, 75(8), 600-612. Chun, O. K., et al. (2021). Dietary antioxidants and the prevention of chronic diseases: what do we know? Annual Review of Nutrition, 41, 313-336. Coyle, D. R., et al. (2020). Nutritional strategies to optimize the performance of female athletes. Sports Medicine, 50(1), 27-38. Dreher, M. L., et al. (2018). Whole fruits and fruit fiber emerging health effects. Nutrients, 10(9), 1235. Gibson, G. R., et al. (2017). The role of the gut microbiome in the regulation of mood and behavior. Psychological Medicine, 47(3), 470-479. González-Muñoz, M. J., et al. (2021). The importance of hydration in women’s health: the role of water and dietary fluids. Nutrients, 13(4), 1203. Liu, Y., et al. (2018). Whole grain consumption and risk of chronic diseases: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Clinical Nutrition, 72(1), 67-81. Mireles, A., et al. (2019). Iron status and its impact on the menstrual cycle: a review. Journal of Nutritional Biochemistry, 72, 1-8. Pérez-Jiménez, J., et al. (2010). The health benefits of whole grains. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(6), 574-586. Rogers, T. R., et al. (2016). The role of physical activity in mental health: a review. Journal of Mental Health, 25(2), 109-116. Slavin, J. L. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 1417-1435. Wang, H., et al. (2016). The role of magnesium in the treatment of premenstrual syndrome: a review. Journal of Women's Health, 25(5), 415-423. Benton, D. (2009). The impact of sugar on mood and cognition. Nutritional Neuroscience, 12(4), 172-176. Benton, D. (2010). The influence of dietary factors on mood and cognition. Nutritional Research Reviews, 23(1), 21-40. Duncan, M. J., et al. (2012). The influence of sugar on mood: implications for obesity and mental health. International Journal of Obesity, 36(6), 825-835. Fisher, D. R., et al. (2019). Sugar consumption and its association with mood and mental health. Nutrients, 11(1), 28. He, F. J., et al. (2013). Salt reduction and cardiovascular disease prevention: a review of the evidence. Journal of Human Hypertension, 27(3), 187-190. Mäkelä, P., et al. (2016). Alcohol and the risk of mood disorders. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 40(1), 165-171. Mozaffarian, D., et al. (2006). Trans fatty acids and cardiovascular disease. New England Journal of Medicine, 354(15), 1601-1613. Smith, A. P., et al. (2013). Caffeine, performance, and mood: effects of caffeine on mood and performance. Psychopharmacology, 225(4), 881-895.
Saperne di più