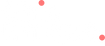Mi ci è voluto qualche anno e una consapevolezza più profonda, regalatami dall’informazione sempre più preziosa e attenta divulgata dalle attiviste che si prodigano in questo ambito per una nuova educazione contro la violenza e per l’eliminazione dei tabù di genere, per rendermi conto che la violenza ginecologica è un fenomeno dalle molte sfaccettature. Esistono quelle più cruente e riconoscibili, ma anche quelle più silenziose, che si insinuano nell’animo in maniera silente ma costante, che esprimono un disagio facendoci costantemente interrogare sulla validità del nostro sentimento.
Facendoci rimanere continuamente sul filo del rasoio, sospettosamente in bilico.
Quelle violenze definibili dalla società “non violenze” che ci fanno domandare: ma è successo davvero o no?
Come se quello che abbiamo sentito o provato fosse qualcosa di esagerato.
Come se stessimo sbagliando a sentirci così.
Il punto è che non stiamo sbagliando.
Ed è il momento di rovesciare la situazione.
Soffro di vulvodinia da molti anni e prima di aver ricevuto una diagnosi adeguata sono entrata e uscita da diversi studi ginecologici senza mai ricevere un riscontro medico attendibile e soprattutto credibile.
Il dolore e il disagio erano etichette sempre nuove e sempre diverse, che mi trovavo appiccicate addosso ogni volta che uscivo da quelle porte.
Il primo ricordo che ho di questo tipo di dolore, risale all’incirca ai miei 15 anni, in concomitanza con i miei primi rapporti preliminari. Di lì a poco mi sarei sottoposta alla prima visita ginecologica. Ricordo benissimo, purtroppo, quel giorno: entrai nella sala insieme a mia madre e vidi questa donna di circa mezza età, che mi disse in modo poco attento alla mia giovane età e senza modi gradevoli, di sdraiarmi sul lettino e nel frattempo mi fece qualche domanda. Pochi secondi dopo iniziò a visitarmi e iniziai a provare fitte e bruciore e lei, come il manuale del gaslighting insegna, disse che il mio dolore derivava semplicemente dal fatto che fossi ancora vergine. Nonostante il mio tentativo di fermarla e di spiegare che fosse qualcosa di troppo doloroso e acuto per essere ricondotto a quello che immaginavo all’epoca essere il "dolore da rottura di imene” – del quale mi ero fatta un'idea in base ai miei stessi rapporti fisici, e grazie ai racconti di conoscenti e amiche –, venni completamente ignorata. C’è da dire anche una cosa importante: sono sempre stata, fino a qualche anno fa, una ragazza incapace di far sentire la mia voce e di combattere per i miei diritti, motivo per cui capirete meglio come, da figure professionali e mediche che dovrebbero avere in mano la nostra salute, ascoltarci e tutelarci, sia stato per me e immagino sia più facile anche per molt* altr*, sentirsi soverchiati, poiché vulnerabili.
Ma torniamo a quella che fu la mia prima visita.
Come avete letto, le mie parole e il mio dolore non furono degni di tanta considerazione ma, come se non bastasse, il tutto si concluse con l’inserimento all’interno del canale vaginale di un ovulo che iniziò a bruciare a più non posso, il cui effetto indesiderato non mi permise di camminare o di scendere dalla macchina per circa un’ora e mezza. Ebbene sì, rimasi seduta sul sedile della macchina di mia madre senza scendere o entrare in casa per tutto quel tempo. In risposta al dolore provato fatto immediatamente presente in studio e alla richiesta di toglierlo poiché insopportabile, ricevetti in risposta un candido “su su, dopo un po’ passa” dalla ginecologa. Inutile dire che da quel momento in poi non misi più piede in uno studio ginecologico per molto tempo, per la paura di riprovare un dolore simile al quale non potevo oppormi.
Il secondo episodio di violenza ginecologica è avvenuto qualche anno dopo.
Avevo all’incirca 19 anni e, dopo continui episodi di dolore che erano ovviamente dissociati dalla mia prima “diagnosi”, avevo deciso di andare in un altro studio ginecologico per ottenere delle risposte e capire se i miei sospetti fossero effettivamente fondati. Questa volta la ginecologa sembrava abbastanza rispettosa e gentile: parlammo molto, io espressi i miei dubbi riguardo quella che era la mia condizione e lei mi ascoltò comprensiva e mi illustrò quello che sapeva della mia patologia (cioè poco o nulla), cercando di farmi capire un po’ meglio come affrontarla in futuro, chiarendo che fosse necessario rivolgersi a uno specialista qualificato. Dopo il colloquio di circa mezz’ora arrivò il momento della visita e, non avendone io fatta fino a quel momento una con attrezzi interni, non sapevo né a che cosa sarei andata incontro e nemmeno che cosa avrei potuto provare.
D’un tratto, senza spiegazioni né attenzione al mio dolore precedentemente illustrato durante il colloquio conoscitivo, la ginecologa infilò lo speculum. Nonostante continuassi a dirle ad alta voce che provavo un dolore atroce e che non riuscivo più a resistere, fino a contorcermi sul lettino, lei proseguì con l’ispezione finché non ebbe finito. Questa esperienza mi è servita per capire che la violenza ginecologica non è solo essere vittime di un comportamento inadeguato, irrispettoso o crudele: si verifica anche nel momento in cui si superano i limiti del paziente per cercare di fare il “proprio lavoro”, senza porre troppa attenzione ai suoi bisogni in nome di un fine considerato giusto, cioè quello di ottenere risposte sulla condizione medica a dispetto del dolore derivante dalle procedure stesse.
La terza e ultima esperienza di “violenza” ginecologica è capitata non molto tempo fa, proprio in concomitanza con la diagnosi effettiva di quello che è il mio dolore cronico. In questo caso, il rispetto nei miei confronti non è mancato nell’ambito fisico, bensì in quello psicologico che ha peggiorato, come un loop infinito, la condizione di quello fisico. Nonostante avessi espressamente richiesto la presenza del mio fidanzato all’interno della stanza in cui si doveva tenere la visita, è stato allontanato senza alcun motivo effettivo ignorando il mio volere, perché, secondo il parere della ginecologa, poteva essere un elemento di disturbo. A smontare questa tesi ci sono due nozioni che vanno chiarite: punto primo, il mio ragazzo è uno studente di medicina al 6° anno ed è stato lui ad aiutarmi a capire meglio la mia malattia e a comprendere cosa stavo affrontando. La sua presenza quindi, oltre ad essere confortante per me, poteva essere un punto a favore per spiegare ciò che io, tecnicamente, non sapevo descrivere, e un tramite prezioso per raccontare come la vulvodinia impattasse la mia quotidianità, da lui vista e osservata da tempo. Punto secondo, di lì a poco, nella stanza in cui si sarebbe tenuta la visita, a mia totale insaputa, ci sarebbero state altre 4 specializzande in ginecologia presenti per tutto il tempo: non solamente durante il colloquio, ma anche durante l’esame stesso, letteralmente piegate su di me. Oltre al fatto di non essere stata minimamente avvisata della partecipazione di altre persone a me estranee in principio, non mi è stato nemmeno chiesto se, data una condizione clinica così particolare, che personalmente trasporta l’agitazione e il disagio emotivo a uno stato fisico che aumenta il dolore, preferissi restare da sola con la dottoressa. Sono stata quindi osservata da 5 persone come un caso clinico da studiare, diventando del materiale didattico da utilizzare per una dimostrazione. Il tutto senza conforto del mio ragazzo per quanto riguarda il dolore che sapevo avrei provato durante lo swab test (un test che consiste nel toccare con un cotton fioc inumidito la vulva in punti specifici e che nelle persone affette da vulvodinia risulta doloroso) che si è aggravato poi a causa della condizione disagevole nella quale mi trovavo perché ero molto tesa. Come se non bastasse, anche la stessa visita è risultata ai miei occhi parzialmente vana perché, a causa dell'imbarazzo provato, non mi sono esposta chiaramente, bypassando alcune cose molto personali che non sentivo di condividere con le specializzande. Quando si dice tanto dolore per nulla.
Infine, le mie esperienze si possono in qualche modo ordinare in fase decrescente di riconoscibilità della violenza. L’evidenza di essere stata vittima di un episodio del genere si è fatta sempre più difficile da individuare nel tempo, poiché da un episodio lampante sono passata a quella serie di domande e dubbi di cui parlavo all’inizio. “Si può definire tale?”, “magari ha solo fatto il suo lavoro” e così via. Quello che però ho capito grazie a questi avvenimenti è che se, in qualche modo siamo portati a domandarci se qualcosa di sbagliato sia avvenuto, forse, è perché è così. Non dico che debba essere necessariamente definita violenza ginecologica qualsiasi esperienza negativa, ma che la cosa importante sia interrogarsi senza paura e dare voce ai nostri dubbi, senza metterli a tacere a priori perché non conformi a quello che fino ad ora ci ha insegnato la società. Siamo noi a dover stabilire i limiti personali del nostro corpo e della nostra mente e, se questi non vengono rispettati, farlo presente senza paura come atto di rispetto verso noi stessi.
MARTA BORASO